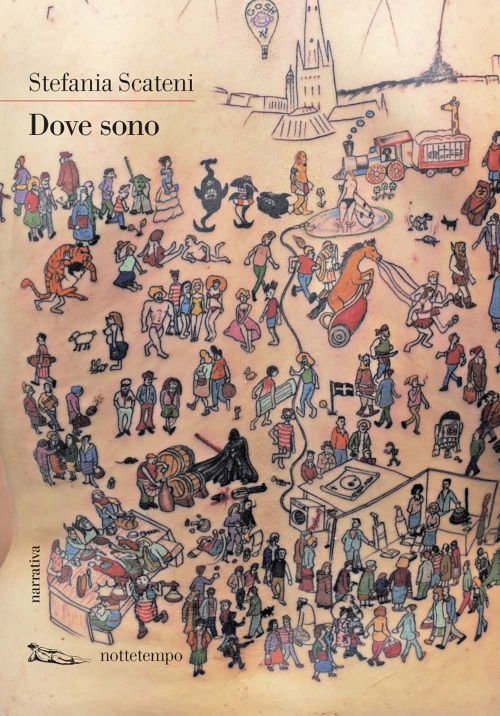
Un romanzo così doloroso, l’ho letto solo con Labambina di Mariella Mehr. Disperato. Senza uscita, anche se questo Dove sono sembra terminare con la speranza: “Dicono i Veda: “Ci sono ancora molte aurore che devono sorgere””. A cui l’io narrante, però, sembra sottrarsi: “Con me o senza di me non ha importanza.” (p.187)
La narrazione della vicenda di Celeste e Filippo, di Santina, Tosca, Delfa, Quinto, Assunta, loro figli, e Chiara, la nipote, e delle ‘tabacchine’ dell’azienda Fat, sta tutta dentro il gesto di un uomo che aiuta una donna a “infilare la giacca”, ma “per l’ultima volta”. Un gesto rituale che nello stesso tempo evoca e impedisce un desiderio di contatto tra Paolo, psicoterapeuta, un uomo chiuso a difesa nella sua rigida routine, e Chiara, una donna aperta al rischio dell’amore: “un modo per toccarsi senza toccarsi” (p.9). La fine di entrambe è apparentemente simile, in una deriva di estrazione dalla realtà canonica, che però per l’uno è perdita addirittura dell’identità di specie (misteriosamente, quasi per contrappasso, incarnandosi nell’ “ippopotamo” di un sogno non suo), mentre per l’altra è ricongiunzione “primordiale” alla trafila tragica delle donne della sua vita, in apparente liberazione dalla “lupa famelica” che strazia e uccide, la quale, però, non scompare, ma insieme a tutte loro si mette a ballare il “tip tap” (p.185). Che mi pare una trasposizione moderna di quei bassorilievi romanici in cui i topi o i galli fanno allegramente il funerale al gatto o alla volpe che sembrano (si fingono o lo sono?) morti.
L’inizio del romanzo, che parte dal taglio netto di chiusura che significa il gesto sacrale dell’aiuto con la giacca, retrocede subito al cominciamento del rapporto tra Paolo e lei. Chi è ‘lei’, la scrivente, la voce narrante, glielo dirà, a lui e al lettore, solo alla fine. La focalizzazione è interna al soggetto che racconta, il tono è essenziale, quasi secco: “Io avevo telefonato. Lui mi aspettava./ Io ero nervosa, lui no./ Ci incontrammo una settimana dopo: lui era nervoso, io no.” (p.9); nella reciprocità inversa delle emozioni, quasi una contaminazione inevitabile, già è dato il segno fatale di un incontro che non può svelarsi, sciogliersi dalle maschere della gentilezza, della cura, delle buone maniere, e farsi carne. Il tono è anche distaccato, oggettivo:
“appoggiai il casco da moto su un’orribile poltrona – la stoffa di una fantasia kitsch, il concentrato del peggio dell’arredamento economico anni settanta (…). Tolsi, in successione, zaino, impermeabile, sciarpona, cappotto.” (p.10)
Un’oggettività che, pure se la focalizzazione resta incentrata sull’interiorità e sulle emozioni, spesso trasposte però su cose e gesti, sembra scarnificare i due protagonisti, anche quando sono definiti fisicamente:
“in quel periodo ero del colore della terra, abbastanza giovane ma non giovanissima (…) piccolina al suo confronto, essendo lui esageratamente alto e anche corpulento. (…) un uomo di mezz’età (…) con barba, occhiali, capelli corti, occhi blu” (p.11).
La soggettività diventa poi ‘terapeutica’, affidata ad un “diario (…) in forma di lettere che non ho mai spedito (…) fogli scritti di getto che conservavo in una cartellina dimenticata”, di cui vengono proposti ampi brani, quasi monologhi interiori. Senza rinunciare ad altri inserti di meticolosa oggettività (“un mobile intarsiato, un pezzo d’antiquariato dell’Ottocento” con “un cassetto per ogni giorno della settimana”; la “cartellina da lavoro di una grande azienda pubblica piena zeppa di fogli. Stampate di computer.” (p.10)), la cui funzione si è già detta sopra. Inoltre la soggettività si diluisce quando è trasposta al plurale di una categoria (“A volte deliriamo.” (p.10)), o quando è espressa nella forma di appunti:
“Fantasia numero1: Adesso mi alzo, gli tolgo gli occhiali e gli bacio gli occhi. (Irresistibile la luce triste e inquieta di quel blu)./ Fantasia numero 2: convincerlo a cambiare gli occhiali, via le lenti gialline (o sono rosine?)/ Pensiero fugace: Indizio. Indizio importante: guarda il polsino slabbrato e consumato del pullover (non è sposato).” (p.14)
O quando diventa veloce sintesi di una narrazione onnisciente (quasi da socio-storicismo, specificamente del ’68) che sa il passato e, giudicando, lascia intravedere il futuro:
“una vita impegnata a concretizzare un sogno (…): liberare i matti. Alla fine, naturale di quell’avventura (…) il mondo era cambiato. (…) Aveva quindi riposto i vecchi allori (…) ora era un borghese, un tantino represso, e viveva una vita regolare, squadrata (…) L’ordine come regola essenziale. (…) condividevo con Paolo sia i sogni che la disillusione” (p.15)
Non fosse per quelle metafore squarcianti che sbattono in primo piano la centralità di un filtro soggettivo grondante di amarezza e dolore: “si ritirò come un pullover di cachemire finito per sbaglio in lavatrice”; “ciascuno a modo suo era stato un pirata di mare (…) E le nostre vite si erano incagliate perché il mare si era capovolto e le onde galoppavano al contrario: eravamo naufraghi” (p.15).
E qui, per la prima volta si adombra un’entità che, come nel mondo simbolico greco, aleggia sempre alle spalle degli attori, contraria, una ‘provvidenza’ manzoniana a rovescio: l’anànke, che traduciamo fato, ma è di più, tremenda e impersonale come i cicli stellari là sugli spalti delle tragedie elleniche dove travolge uomini e dei, tremenda e appena più connotata, qui, da uno storicismo di classe, dove si abbatte sugli sfruttati, sugli emarginati, sulle donne soprattutto; di più perché comunque sempre negativa, “bestia”, intrinseca alla vita, gemellata se non medesima alla morte, irridente come il nome ‘Provvidenza’ della barca dei Malavoglia. Che viene nominata a capo del secondo capitolo con la maschera di Atropo, “la vecchia che taglia i fili delle vite umane”.
La narrante soggettiva, qui, al momento di dare tutto lo spazio alla storia apparentemente ‘altra’, (ma solo ‘altrimenti’ raccontata), di Celeste, Tosca, Delfa, Assunta, Veronica, entra direttamente in scena, si fa personaggio con un ruolo registico:
“Tu la conosci bene questa storia (…) hai mosso le fila di questa storia di campi e riccioli rossi, di seni gonfi e ventri svuotati, (…) di madonne e contadine, (…) di lievito e putrefazione” (p.17)
Anche lei pirandellianamente trascinata a testimoniare (“la devo raccontare, me l’hanno detto, me l’hanno chiesto” (p.18)), ‘da fuori’, onnisciente burattinaia (“Ero straniera in quella casa (…) Ed è stato là che mi hanno chiesto di raccontare.” (p.18)) di una vicenda altrimenti sepolta “nei loro silenzi, nei gesti, nelle trame delle loro tele” (p.17). ‘Loro’ sono donne, quelle che “ne sanno una più dei poeti, ne sanno una più di Atropo”, nonostante la loro storia straziante, o forse proprio per questo, perché i “fili tagliati, le donne li raccolgono e li intrecciano, li ordiscono in nuove trame, nuove vite, nuovi racconti” (p.18). Bellissima affermazione che però non trova molto riscontro nella vicenda del romanzo.
Qui, dichiarata, avviene una cosa nuova nella forma narrante: anche se sembrerà scomparire nell’oggettività, o anche comparire manzonianamente dall’‘alto’ con interventi, precisazioni (a mo’ di quelle specificatissime ‘gride’ dei Promessi sposi), giudizi, interludi col lettore, la narrante sarà una di loro, avvertita ‘sottopelle’ più che precisamente individuata (già si è detto che la ‘rivelazione’ della sua ‘parte’ avverrà solo alla fine della storia, quando ‘lei’ diventerà di nuovo ‘io’), ma intrecciata a loro da una condivisione del dolore che assorella più del sangue.
L’ingresso alla vicenda è verghiano: “Tutti dicevano che era stata una famiglia sfortunata.”. Subito ricondotto a chi sa, dirige la narrazione: “E dicevano la verità.”. Che compie subito anche un’altra azione formale particolare, per cui l’ambientazione è connotata da una formula che sarà anaforicamente ripetuta come un leitmotiv: quei “monti né troppo alti né troppo bassi” del circondario e quella “città nella valle” che da essi pare assediata. Da una parte la reticenza che tace i toponimi depista da una spazialità che è troppo vera per essere dichiarata (l’impressione di un forte autobiografismo è più di un sospetto) ed inoltre sospende la narrazione in una localizzazione adatta ad una trasfigurazione mitica, che, coscientemente o no per la narrante, pare in effetti, se non un preciso obiettivo, una tensione inarrestabile, per come è sentita, vissuta, denunciata, e infine trasfigurata, la vicenda-destino non solo delle donne di questa famiglia, non solo di tantissime donne delle classi più basse, ma di tutto il genere delle donne.
“E anche la polvere cominciò a roteare, come fosse un banco di sardine che danzava nell’oceano, come fosse un tornado in una bolla di vetro (…) Entrammo tutte nel vortice (…) un mulinello di aria leggera e gentile che ci prese (…) senza farci male e ci sollevò da terra. (…) Mentre danzavamo ridendo e scomparivamo tutte dentro il celeste, sentimmo le nostre voci (…): “Ci spediamo tra il pulviscolo del mondo. Ci rimescoliamo nel fango primordiale. (…) Ci restituiamo alla nostra natura. Terra, cenere, morte, vita, bellezza./ Ci riportiamo a casa.” (p.187)
Ma d’altra parte la medesima reticenza può essere sentita anche come riferimento così consueto, da non dovere essere definito; dà, cioè, un senso di vita vissuta, di certificazione fisica, empirica, oggettiva, ma con l’insistenza su un ritorno uguale e monotono dell’abitudine, che non può non richiamare simbolicamente la chiusura, la destinazione fatale a cui, appunto, l’io narrante tenterà di sfuggire.
Poi ha inizio la storia della famiglia con Celeste e Filippo. La narrazione onnisciente spesso anticipa l’evoluzione degli eventi:
“nel caso di questa famiglia sfortunata, morte ha stravinto (…) Sempre appostata, (…) con la grande bocca senza labbra e senza lingua, un buco nero spalancato a pregustare il banchetto” (p.20)
Magari con stilemi da verismo, come il parallelo col mondo esterno per rendere la devastazione sociale e interiore:
“Avete mai sentito le urla del maiale colpito a morte da un punteruolo conficcato nel cuore? (…) I contadini hanno a che fare sempre con la morte./ La morte è dappertutto. La morte è. La morte dolce delle piante (…) O la morte più cruda, più vicina al nostro destino, degli animali. Amati e uccisi. Benedetti e scuoiati. (p.20)
Il suo seno era ancora gonfio di latte. (…) Diventò duro come la pietra del monte nero, come il cuore dei contadini, come la terra argillosa dei campi ai piedi dei monti né troppo alti, né troppo bassi” (p.21)
Parlava meglio con le mani, che sapientemente intrecciavano le budella dei polli perché il sugo si insaporisse bene e tagliava tagliatelle sottili e regolari che neanche un architetto avrebbe fatto meglio. (…) Con i capelli bianchi e la testa su un altro pianeta (…) riuscì infine a sfogare la sua rabbia ormai rinsecchita (…) colpendo le automobili parcheggiate ai bordi della strada col suo bastone” (p.25)
Ci sono inserti quasi documentaristici che denunciano la vita e lo sfruttamento dei contadini mezzadri, le condizioni del lavoro, la subalternità umiliante ai padroni delle terre. Il linguaggio è allora decisamente socio-politico, in alcuni punti con vere e proprie espressioni dell’oralità dei contadini: “Mezzadria voleva dire “fare a metà”. Ma al momento del raccolto c’era sempre qualcosa in più o di meglio per il padrone.”. Oppure con espressioni da slogan socialisti: “Quella casa non sua, quella terra non sua …”, magari legate ossimoricamente a espressioni dell’intimità emozionale: “…. Celeste l’amava come una parte di sé” (p.23).
Col trasferimento alla “città nella valle”, entra in campo la FAT, la Fattoria Autonoma Tabacchi e la narrazione prende i toni della denuncia critica sindacale:
“con il paternalismo e l’arroganza di chi dà da mangiare alle famiglie, demolì case, ristrutturò edifici e cancellò persino una strada (…) E aveva sempre più bisogno di forza lavoro. Erano quasi tutte donne gli operai (…) le chiamavano tabacchine. Fumavano tutte. (…) Il lavoro si manteneva con l’arte dell’obbedienza.” (p.33)
Siccome la FAT assume “per chiamata”, vengono riportate alcune domande tipiche di assunzione, ma soprattutto, più avanti, suppliche di riassunzione, di ‘perdono’, quando una ‘punizione’ per scarso rendimento o per il delitto di manipolazione errata delle preziose foglie di tabacco porta al licenziamento in tronco. Sono “vere e proprie suppliche, accorate, strazianti”, scritte in un mistilinguismo che associa la retorica burocratica ai modi della implorazione d’aiuto dei derelitti rivolta a potenti, istituzioni o santi, insieme a profferte scongiurate di stima, di fedeltà, di speranza cieca. Sono riportati anche brani delle motivazioni di licenziamento della FAT, che sembrano presi da sentenze dell’Inquisizione o da resoconti polizieschi: “per aver malignamente ridotto a frasami delle foglie integre di tabacco”, “si è resa ripetutamente colpevole di turbamenti al normale andamento della lavorazione” (p.68). E che sembrano, come le lettere, venire da una documentazione reale dell’autrice. Ci sono poi, inframezzate alle regole per distinguere e maneggiare alla perfezione le foglie di tabacco, le giaculatorie di raccomandazione alla Madonna, all’Agnello di Dio, al Tempio di Gloria, ecc., che le donne recitano come formule magiche contro gli incidenti e gli errori e le multe. Perché “Bisognava essere produttive. Bisognava essere precise. Bisognava essere veloci.” (p.43). E attente nella “guerra” di “tutte contro tutte, ma soprattutto con le caposquadra, le caporeparto, le maestre, cape, sottocape e capette, che controllavano il lavoro, ed erano spietate.” (p.45). La FAT nel procedere della narrazione, se non prende il suo posto, si gemella alla morte, all’eterna affamata “dei poveri e dei malati, dei bambini e delle donne” (p.47); come essa ‘aleggia’ sempre sulla famiglia protagonista, così la FAT si appropria, l’una dopo l’altra, delle sue donne: “Spesso alla FAT il lavoro passava di madre in figlia” (p.58).
In mezzo, a tratti velocissimi, le vicende che vanno avanti delle donne (e uomini) di famiglia. Quasi fuori contesto, eccezione in quella famiglia sfortunata, compare una doppia figura quasi mitica: la coppia di sorelle belle “Come la Lollobrigida, come Sophia Loren”, “Tabacchine al mattino, principesse il resto del giorno.” (p.46). Rossa, bellissima Tosca, dalle mani magiche, che sa fare in un modo quasi da rituale d’incantamento la sfoglia e la pasta. La sfoglia, nelle varie fasi della sua creazione, e la pasta da essa ricavata, sono descritte come frutto di un’arte speciale, in un vero e proprio rito, con pause, balletti, giochi di prestigio, che possono divenire “moneta di scambio”: “La donna che fa la pasta è dio, un dio femmina, la spianatoia il palcoscenico sul quale la domenica viene rappresentata la nascita della vita, vita per sé e vita per gli altri” (p.35). Ma questa dote non sarebbe bastevole comunque a salvare la maga dell’impasto dal destino di donna che la madre Celeste profetizza: “Siamo destinate a creare per gli altri. Che siano lenzuola o quadrucci. O bambini.” (p.36). Delfa, un po’ più timida, incanta chi guarda il suo viso, “e il seno e i fianchi e le gambe e il sedere e l’andatura (…) forte e sinuosa” (p.48). Ma la morte non si stacca quasi mai dalle tegole della loro casa al “centro della città nella valle” (p.48)[i].
Se questa parte è una delle meno ‘lavorate’ letterariamente del romanzo, mantiene comunque un ruolo fondamentale, non solo per la puntualità dell’ambientazione sociale, necessaria – come prima la descrizione della condizione contadina – a delineare il passaggio a un nuovo fondale socio-economico, ma soprattutto per la funzione di immettere la vicenda della famiglia in una dimensione corale che toglie i personaggi dalla individualità tragica della tragedia antica –anche la morte, che qui affida agli “esseri umani” parte del suo lavoro. Gli eventi della famiglia, adesso è come se si allargassero alla comunità: non solo della FAT, ma della “città nella valle”: con il nipote della zia edicolante all’angolo della piazza, Costanzo, impiegato alla FAT, che si sporge dalla “finestrella”, sovrastata da L’Unità, “per affacciarsi verso il panorama della domenica”, in quella vera e propria “agorà”, dove i ragazzi parlano “fitto (…) di tabacco pesante e tabacco leggero, (…) ma soprattutto di donne”, dove “sia i fedeli che i non fedeli” si fermano “a fare due chiacchiere” (perché lì “il potere politico, comunista, e quello religioso, cattolico, convivevano senza imbarazzi”), quando la “messa era uscita, come si diceva”. Con Quinto che corre davanti al “palazzo antico” dagli splendidi “ghirigori” – “gigliucci, fiori, arabeschi” – per arrivare primo ad abbuffarsi degli scarti del lavoro del pasticcere o per andare a prendere il padre ubriaco, Filippo, e riportarlo a casa, da sua madre Celeste, ormai “impazzita dal dolore”, che per lui “non c’era, non lo vedeva, non lo sentiva” e che lo fa sentire bene solo per strada o comunque in un altrove lontano da casa, anche se poi diventerà un’altra ‘prigione’: purché, appunto, sia collocata altrove (pp.56-65).
La narrazione onnisciente della nuova coralità si è interrotta solo per uno squarcio sulla interiorità di Celeste, in un monologo interiore da tragedia shakespeariana, non annunciato, non commentato, ma buttato sulla pagina quasi un esondante flusso di coscienza, gravido di un dolore radicato, subito, fatale, che ne fa in effetti la postura intima di ogni membro della famiglia, la metafora della loro condizione umana e sociale, compresa la soggettivissima emersione biografica della narrante:
“Arancio verde marrone. I colori delle foglie. Giallo anche. Fuori c’è il sole. (…) Non si vede niente, nessun panorama, nessuno squarcio di luce. Le finestre sono in alto, strette come fessure. La luce viene dalle lampadine. Questo mi fa venire tristezza. Mica pensare che a casa tra un po’ arriva mio marito ubriaco (…). Mica pensare che mancano tante cose a casa. La luce che manca mi dà tristezza. (…) Il vicolo è stretto e le finestre al piano basso non catturano che qualche avanzo luminoso dei piani più alti.” (p.63)
Ma è con un altro, altrettanto improvviso e non attribuito specificamente, ‘flusso di coscienza’ per così dire, – di una narrazione oggettiva, se mi è concesso l’ossimoro, peraltro non a grado zero, ma proprio dentro gli occhi e gli orecchi della “città nella valle”, verghianamente – che viene introdotto, ora molto più addentrato più partecipato, il personaggio corale delle donne che lavorano alla FAT:
“Le sette meno cinque./ C’era la fila… a tre… a cinque… a sei… quasi tutte donne, tutte vestite uguali, stessa divisa, stessi colori. Degli uomini, sparuta minoranza, si vedeva solo il cappello. (…) Le donne col fazzoletto in testa, come se seguissero il prete che regge il crocefisso. Bello… una processione, azzurra e marrone. Nessuno pregava però. Anzi, qualcuno smadonnava. Il rumore di fondo era un chiacchiericcio di donne, tanto per sfogarsi, che poi una volta dentro non si può fiatare. Zitte! Bisogna essere veloci nel lavoro. Concentrate! L’occhio fisso e vigile sul lavoro. Delicate! Mani di velluto, che se no si rovinano le foglie. Altrimenti sono punizioni: richiami, prediche, multe e sospensioni. E poi, a fine giornata, bisogna persino andare dalla maestra o addirittura dal direttore a chiedere scusa, promettere che non lo farai mai più, che d’ora in poi sarai silenziosa, attenta, veloce, concentrata, delicata. Perché il lavoro è pane e il pane non basta mai.” (pp.65-66)
E come in un diramarsi ai singoli soggetti –Isolina Rosa Adele Cecilia Idolina Rosmilda Elide Delia Doriana e Assunta (la sorella piccola della famiglia), tra loro – prima le lettere di supplica a cui accennavo sopra, di cui si dice il nome della scrivente e in due righe la sua vicenda (non posso non sentirci la maniera degli annunci mortuari, solo, qui, in una davvero dolorosa condivisione). Poi, nell’inferno delle durissime condizioni del lavoro, viene fermato il gesto di una, la voce di un’altra, la preoccupazione generale, ognuna con il suo carico di fatica e paura, vera e propria dannata della terra, per dirla alla Frantz Fanon, che proprio in quegli anni scriveva la sua denuncia al mondo.
Entra quindi in scena Veronica, designata al suo destino dalla connotazione di “figlia di madre pazza”, quarto parto di Celeste, che la allatta “con svogliatezza” e la trascura, lasciandola alle cure dei vicini, che possono viziarla di “noccioline” e coccole, ma non darle la famiglia di cui avrebbe bisogno. Veronica diventa una ragazzina “yé-yé”, “beat, jeans e capelli corti”, con i dischi dei Beatles, dei Rolling Stones, di Nada ecc. che fa sentire alla nipote (figlia di Assunta: c’è un notevole excursus al futuro), sul mangiadischi, dentro la Cinquecento, sua “discoteca a quattro ruote”: è tracciata la sintesi di un’epoca, sono gli anni Sessanta, del boom. Nemmeno il rinnovamento sociale può salvarla, però, Veronica: “Veronica tanti fidanzati e nessun marito, Veronica tre lavori e nessun lavoro, Veronica una mamma e nessuna mamma”, che infatti arriva infine a decidere che
“vivere è occuparsi di una madre che non ti ha voluto, vivere è un cappuccino a merenda, vivere è fumare e poi smettere di fumare, vivere è comprare un pupazzo di Babbo Natale ogni Natale, vivere è diventare una madonna di legno”
Le anafore qui, così asfissianti, rendono bene con il loro monotono incalzare l’accoglienza da parte di Veronica del “dono” della madre, la depressione. Con la quale –madre e depressione – condivide “il letto matrimoniale” fino alla morte di Celeste. E, dopo, è una resa continua (“smise”, “cessò”,” chiuse”, “chiuse”, “chiuse”) fino al cancro, che ignora fin che può, fino al ricovero a Villa Bettini, “un centro per anziani e malati soli (…) ex ospizio”, “carcere, manicomio e ospedale. Sentore di disinfettante, odore di brodino e gelido indizio metallico del carcere”. La narrazione lo descrive dettagliatamente, fisicamente figura per figura:
“la bocca a penzoloni, come i piedi (…) ripetono venti volte la stessa frase (…) una vecchia senza il naso (…) una grassona che urla sempre (…) una vecchietta piccola piccola che cammina incessantemente su e giù (…) la grande schiera di chi chiede. C’è chi chiede (…) C’è chi cerca (…) C’è chi non riesce (…) e chiede (…)”[ii]
Tragicamente:
“dove si aspetta la morte (…) fantasmi o relitti sono lì per aspettare che morte arrivi. Non fanno altro. Aspettare. Aspettano qualcuno che le porti via, aspettano qualcuno che le vada a trovare, aspettano qualcuno che regali loro un cioccolatino o una sigaretta, aspettano che arrivi tu.”
E in una forma del tutto nuova, una forma poetica alla maniera dello sperimentalismo ‘novissimo’ degli anni Sessanta e Settanta:
“PRIMA…// Non voglio stare sola./ Nel ripostiglio cinque buste di vestiti sporchi nel ripostiglio/ Sul tavolo sei bucce di banana sul tavolo/ In cucina la televisione blu è muta in cucina// Il letto ora è a una piazza/ E gli armadi sono due/ Un bottone non c’è più/ E l’altro ha un pessimo odore/ Le parole sono colpi di tosse/ In cucina la televisione blu in cucina è muta// Non voglio stare sola/ Voglio una televisione accesa e qualcuno che la guardi aspettando la cena/ (…)/ … O POI// Zucchero 12/ Caffè 49/ Sedia nera/ “Rose rosse per te/ ho comprato stasera”// Mi dai una sigaretta?/ Volevo dire/ Mi dai una sigaretta?/ Mi dai una sigaretta?/ Mi dai una sigaretta?/ Buona Pasqua/ (…)// Facciamo il corridoio/ Signora! Signora!/ Me lo apre?/ Quella troia, quella maiala/ Signora! Me lo apre?/ Volevo dire/ Facciamo il corridoio/ Facciamo il corridoio/ Facciamo il corridoio (…)”[iii]
Le anafore, ancora, e la cadenza sintattica a riprese e paralleli – a questo punto accertate come la più marcata firma stilistica di Scateni –, qui, se ritmano il monotono scivolare della vita alla morte, però a sbuffi, come colpi di tosse, denunciano un attaccamento alla vita che commuove nel profondo. Ma questo stilema raggiunge un apice di notevole e originale potenza nella narrazione della morte di Veronica:
“Mangiava minestra, stracchino e purè. Poi solo stracchino e purè. Poi solo purè. Finché, senza un lamento, smise di mangiare, poi di muoversi, poi di ansimare, poi di respirare.”
(Citazioni pp.77-90)
La narrazione onnisciente torna indietro per recuperare la vicenda di Assunta, l’ultima delle sorelle. “Un viso alla Julia Roberts (si direbbe oggi)”. E invece si sente e crede brutta, ma ha un “sorriso capace di far tintinnare i sonagli degli angeli” (pp.92-3). Lavora alla FAT, conosce Costanzo, ‘vespista’ accanito, lo sposa, si sottomette completamente a lui e alla suocera “feudataria”, partorisce Chiara che da subito detesta per il dolore che le ha procurato, poi ‘si abitua’ a lei, “a far finta di volerle bene” (p.99). Un disamore reciproco, perché la figlia ‘si vergogna’ della madre e della sua famiglia. La casa della nonna le fa paura, ogni vicino come un mostro da temere. Le interessa solo ascoltare i dischi nell’auto della zia Veronica. Alleata del padre manesco, isola nel silenzio la madre, con cui sta volentieri solo quando vanno in giro a rubare vasi di fiori, o quando si trovano con le donne del vicinato dalla sarta Narda, un vero gineceo dove
“Narda tagliava e cuciva, le donne tagliavano e cucivano con la lingua e con le mani intente com’erano a operazioni semplici, cioè soprammani, sottopunti, orli e imbastiture”
E dove Chiara può godere dell’“odore di filo e stoffa appena stirata” e dei
“movimenti ripetuti e morbidi di quella schiera di cucitrici con l’ago in mano, gesti ritmici come una danza popolare, fluidi come una canzone cantata in coro, ipnotici come un rito sacro. (…) una tavola rotonda al femminile, dove le donne parlano e tagliano, uniscono, dividono, increspano e spianano. Creano.” (p.102).
Assunta non si ribella mai a una vita che non le dà niente. Si limita a “lamentarsi. Lamentarsi sempre.” (p.104)
Di colpo, come ho anticipato all’inizio, il racconto torna nella voce della donna che lo sta porgendo a Paolo, come una rivelazione:
“Io sono l’ultima di quella famiglia (…) Perché io ho quelle donne dentro. Ho la loro morte dentro (…) Io sono Chiara. Ascolta.” (p.105, p.107)
Ma in realtà, anche se apparentemente chiede e spera che quell’uomo la aiuti a vincere la morte, in realtà, da come lo presenta adesso – “affascinante nella sua sbilenca stabilità” –, non si prospetta capace di tanto;
inoltre quando lo definisce l’unico che in continuità “ha spiato, seguito accompagnato e masticato[iv] le vite” (p.105) delle donne della famiglia, gli sovrappone la maschera e le maniere antropofaghe della morte eterna affamata. Ed è infatti alla morte che poi direttamente si rivolge, tramite parole colte e tramite parole proprie, di attacco/sfida, di supplica. Perché sta per raccontare la sua fuga dal “contagio”, dalla “vergogna della follia o semplicemente la vergogna della sfortuna” (p.108). Ma in una narrazione adesso intimissima, con respiro leggero e scavo profondo, che mi ricorda certe pagine di Lispector, Chiara, anche attraverso lacerti di ricordi infantili, spinge le sue domande ai limiti estremi dell’esistere:
“giocavo con quel che c’era di vivo, fiori, sassi, insetti. “Minerale, vegetale, animale” (…) Tutta la vita sta in quella triade (…) Anch’io ci stavo in quella triade, insieme alla terra dell’orto, alle mosche, alle lucertole, alle spighe di grano e ai noccioli delle pesche. Tutti nello stesso universo. Una grandezza che non riuscivo a comprendere, una vastità così vasta che per forza doveva essere indifferente alle sue creature: dove trovava il tempo per occuparsi di tutti, come faceva ad avere compassione? E allora, siamo soli? Sono sola? Ti buttano nuda e scalza nell’universo, poi sono affari tuoi?” (p. 109)
Ripensa a quando da bambina afferrava e poi liberava le api, per sentirsi nel piacere dell’onnipotenza, e quando metteva in un cartone insetti e animaletti anche nemici tra loro, per poi, i sopravvissuti, liberarli nel campo d’origine. E ricorda il terrore e il dolore di quando il padre per la prima volte fece uscire dall’armadio, “dall’oscurità”, una canna di bambù, “flessibile” e sibilante “come un serpente” per colpirla con
“bruciature, ustioni che dalla pelle si irradiavano all’interno del mio corpo, nelle viscere sgomente. Perché io non riuscivo a capire. Non capivano, le mie viscere, perché. (…) la canna di bambù diventò il nuovo terribile, imprevedibile uomo nero.” (pp.113-4)
La madre si limita a tirale i capelli e a farle indossare troppo lunghe scomode gonne a pieghe. Ma entrambe i genitori le costruiscono la distruzione dentro di lei: “Lo so che ero io./ Dovevo avere un guasto dentro che solo i miei genitori riuscivano a vedere.” (p.117).
Poi Chiara diventa “grande”. E se, ancora con le consuete anafore, “da grande” il padre la picchia, punisce, critica, controlla, ecc., arriva un giorno che lei risponde al ceffone con uno schiaffo: “Avevo diciotto anni./ Non mi toccò mai più.” (p.121) Ritorna ancora, minuziosamente, quasi nello stile oggettivo di chi dà indicazioni di metodo, sulle morti degli animali domestici a cui nell’infanzia ha assistito e che, dice, l’hanno abituata alla morte.
“Quella era la morte. Buona da mangiare. Bella da guardare. Fulminea. (…) cercavo di capire il passaggio dal sì al no, dal fiato al nulla, dal mobile all’immobile. (…) La cerimonia della crudeltà e dell’abbondanza. (…) Si facevano il segno della croce prima di accomodare i prosciutti (…) La morte del maiale aveva un ottimo sapore.” (p.125, p. 129)
Ma generalmente “Degli uomini, invece, non si fa nulla (…) rimane una foto, un nome scolpito sul marmo e fiori sfioriti (…) Così pensavo.” (p.129) Lei, ha però capito, adesso, che i morti possono rimanere in modo ben diverso:
“li sento dentro di me. So che alcuni di loro sono vicini, mi accompagnano (…) Così come sono vicine le donne di quella famiglia sfortunata. Mi appartengono. (…) sono arrivate tutte insieme (…) Hanno avanzato una grande pretesa rivolgendosi a me, io che le ho sempre scansate dalla mente, che ho provato vergogna e disagio per loro, che le ho allontanate dalla mia vita. O così credevo. (…) Era un invito a raccontare la sua [loro n.d.r.] storia? (…) perché, se esiste un sapere delle donne che si intreccia nel tempo come i fili di un telaio, perché non dovrebbero tessere la loro tela anche le morte, le scomparse, le ombre? (…) Anche i fantasmi possono sanguinare.” (p.131-2)
Mentre si delinea il rapporto conflittuale con Paolo (lui “ambiguo e scoperto, incapace di mantenere il ruolo [di psichiatra, n.d.r] fino in fondo. Oscillante e sul punto di scoppiare (…) sembrava dire sì e sembrava dire no”; lei che da “anarchica bombarola”, oltre alle proprie, gli disinnesca le “bombe”, aprendo “innumerevoli falle”, ma patisce tutta l’ambiguità di un rapporto che non può essere di amicizia, né di amore, pur essendolo – “soffocato”–; fino alla “perdita dell’autostima” che è di più, se dalla prima persona il soggetto passa alla terza, e in una pioggia anaforica di “vedeva” allo specchio, diventa “bestia” (pp.136-8)), è raccontata l’esperienza giovanile e successiva: di lui svelta svelta, quasi a sommario (“sessantottino militante”, “pioniere della psichiatria basagliana”, rivoluzionario di manicomi, poi inserito nelle istituzioni e via via ingoiato da frustrazioni e rese); di lei, ben più diluita, (studentessa “sovversiva” del ’77 alla maniera non eclatante della periferia, dove non arrivano “le cose brutte, le pistole, le botte, i lacrimogeni, i deliri, i morti” (p.146); poi in fuga dal trantran borghese della città nella valle, ma soprattutto dal destino della sua famiglia, verso la capitale, verso il ‘movimento’ o quel che ne resta, e il femminismo, che troverà puntualmente entrambe a deludere le sue aspettative).
La delusione più cocente è proprio nella rottura del rapporto tra lei e Paolo, da lei con fatica simbolicamente organizzata, quando lui le ‘scippa’ il congedo con un discorsetto tanto rivelante quanto vigliacco. È avvenuto qualcosa di talmente grave – ‘‘non avevamo coltivato l’amore” (p.163) – da essere paragonabile al peccato di ùbris delle tragedie greche.
Si apre l’abisso.
Una voce, come altra-da-sé, le sussurra dentro: “e liberaci dal male”. E prega. L’anafora “Ha pregato per” (pp.163-4) introduce una sequenza di categorie antinomiche in cui continuano ad affrontarsi lui e lei, e poi tutta l’umanità, quasi una sorta di disperate ‘beatitudini’ che inneggiano all’amore, in tutte le forme che lo cercano e lo negano. Non c’è possibilità, non c’è rimedio. E “l’ombra” che credeva di avere “lasciata sopra la casa sfortunata”, “lo spettro”, la “bestia” scopre che ce l’ha “in corpo” ed ha “aperto gli occhi” (p.167). Azzanna tutto di lei, identificandosi addirittura con lei: “Io, l’assassina, la donna che uccide, la strega, l’arpia, la cieca che regge le forbici, la sirena dalle zampe di gallina. La madre mortifera… la maledizione, inutile sfuggirle (…) La pensavo sempre. La invocavo.” (p.167) E di nuovo una contraddittoria sequenza anaforica di “Non volevo” che chiamano alla resistenza, e di “Volevo” che abbandonano all’inerzia, alla fuga dal “male di vivere” per l’unica via dell’annientamento di sé. Addirittura, poi, in pagine soggettivissime – e lo stile, se non lo è davvero un diario della scrittrice, è quello di un diario del crollo psichico – si sdoppia tra chi racconta e chi è raccontata e, alla fine della storia, eliminata: come un male da estirpare, un favore dovuto al mondo. “Suicidarmi per non morire” (p.177).
Ed ecco una nuova sequenza che, introducendo un soffio di autoironia (“Ma non ero” e sono elencate tante grandi poete e scrittrici suicide), approda alla impossibilità di uccidersi: “Avevo bisogno di un Ufficio Sopravvivenza dove trovare un manuale con le istruzioni per guarire da questa nuova condizione esistenziale (desistenziale? inesistenziale?)” (p.178). E infine arriva alla visualizzazione di una polvere danzante che le si muove intorno come “uno stormo di storni” (p.180), o come “una pubblicità del Martini” (p.182), in diversi momenti di una vita che comunque ha ripreso a vivere, con amici, lavoro, sigarette. In quella “danza della sabbia” comincia a ballare anche lei; la sente “infinita. Vita, morte, vita.”, mentre si staccano da lei i brandelli della storia fatale che l’ha inseguita e prendono corpo gli atomi positivi che pure ha avuto ed ha.
Potrebbe, vorrebbe essere di sicuro un finale lieto, salvifico, anche proprio quando arrivano tutte le altre donne della sua vita e non solo, nel loro migliore aspetto, e si mettono tutte dentro quel vortice danzante con api e farfalle.
Non fosse per certi strappi tra i volteggi[v]: “Amare (…) è ballare con la morte, motore del movimento dell’universo: ogni cosa svanisce” (vero è che aggiunge “e quel che rimane rinasce in altri modi”, ma “per confondersi ancora con la polvere dell’universo ed essere di nuovo concepito.” (p.184): la mia impressione è che prevalga l’immagine di dissoluzione).
“E, finalmente, ci raggiunse anche la lupa famelica, tutta pelle e ossa. La bestia (…) mi disse: “Danza questa danza, io conosco i passi” “(p.185). Quelli appunto, di cui dicevo all’inizio, del “tip tap”.
E ancora: “Mi perdevo dentro a quella danza”. Soprattutto una domanda drammatica, che non a caso poi dà il titolo al libro: “Donne, dove sono io?” (p.185). Non importa che subito attenui con “una storia da ridere” da cui ha preso la battuta, né che racconti come con una telefonata si riprenda il congedo da Paolo, ancora attraverso una serie di anafore – “Voglio” – con cui afferma i suoi bisogni e lo esclude dalla sua vita: “ho appoggiato i piedi nel mondo” (p.186). E non perché comunque lui non capisce niente, quasi annullando la portata della sua rivincita; quanto, piuttosto, visto che lo ha già disintegrato in pagine prima, raccontandone la sua futura tragica caduta demenziale, che lei senta le parole di lui ancora “dolci e bellissime”. Vero, vero, possono essere connotazioni ironiche, come se fossero parole dette da un demente incosciente, ma. MA.
Infine mi fa tremare quel roteare di tutte loro “a un palmo dal pavimento”. Sì, una trasfigurazione simbolica, o spirituale, o metafisica: se devono arrivare “al celeste e al trasparente”! Ma di sicuro in un altrove dalla vita.
Dove – e questo perché Stefania Scateni lo mette a chiusura? – “Con me o senza di me non ha importanza.”.
Donne, lettore e lettori, mi dite se questa mala sensazione è sbagliata?
[i] Evito di precisare alcuni avvenimenti per non togliere ad eventuali lettori il gusto della lettura.
[ii] Mi viene in mente la drammatica e bellissima sezione di Abse, Ospizio femminile, ma anche la sezione dentro la O del mio manicomioarca di dentro la O,dove Anna Maria Farabbi sembra entrare e guardare e condividere a fianco di Stefania Scateni.
[iii] In questo doppio titolo “PRIMA… O POI”, avendo sentito accenni alla attuale difficile condizione di salute e di vita di Stefania Scateni, non posso non avvertire qui anche una sua dolorosissima personale prospettiva.
[iv] Mia sottolineatura.
[v] Le sottolineature sono mie.

Lascia un commento