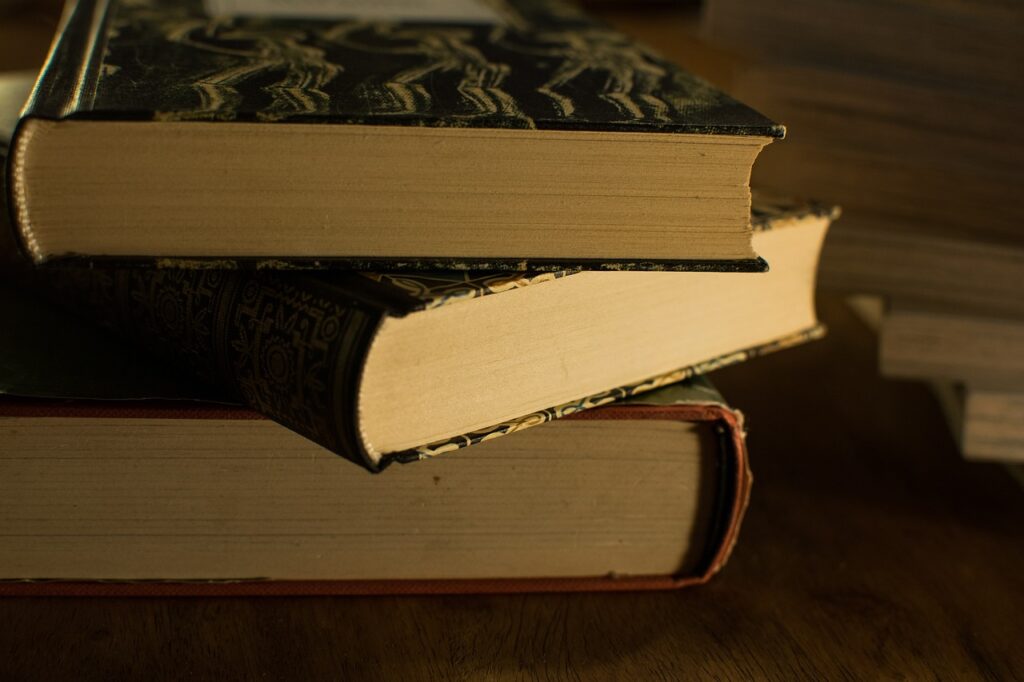
Premessa introduttiva:
Da tempo coltivavo l’aspirazione a raccogliere in un agile volumetto i poeti che avevo particolarmente a cuore, focalizzando la mia attenzione soltanto su alcuni dei loro testi più significativi ed esemplari allo scopo di proporne un serrato commento critico. Ne è uscito un libretto di un centinaio di pagine in formato tascabile, tuttora inedito, dedicato ad analisi su 13 liriche di altrettanti poeti italiani, viventi e anche no, con un’attenzione particolare ai dialetti.
La loro genesi, tuttavia, resta legata alla mia attività didattica di insegnante: le avevo concepite, in origine, come analisi del testo cui sottoporre i miei studenti, naturalmente in forma molto diversa, ovvero come quesiti mirati sul testo.
Ho provveduto in seguito a dare una veste argomentativa a tali cataloghi di domande e il risultato è costituito dalle chiose critiche che seguono. Alcune, fra quelle più corpose, hanno già avuto un’anticipazione su rivista; per CartaVetro ho preferito orientarmi su commenti meno estesi, ma non meno curati.
Va aggiunto, ad onor del vero, che il lavoro mi era stato commissionato dal Ponte del Sale di Rovigo per la collana “Saggi in 32”; purtroppo la lievitazione dei costi di stampa ha costretto l’editore a sospendere le pubblicazioni previste per tale collana, ragion per cui, col consenso del Ponte, mi sto muovendo anche in altre direzioni.
Loredana Bogliun
La ca∫a d’al monto
In seima al monto ouna ca∫a. Vudia
Vudia ∫ì sta ca∫a soun al monto
ch’a la se di∫gourba a peian a peian
cul vento ch’a ghe favela in tala pansa vudia
∫bourtandosse drento par sircala, magnala douta
El ghe fa frido ai mouri ∫biadeidi de fiuri
ch’a se rampiga in feila cumo par ricamo
soun par la reiga de le scale sfassade
Spoussa de ∫ento ch’a no se sento pioun
Soun al monto no ∫ì pioun gnanca ledan
de la vaca, al gal ch’a te ciama bunura
Scuverto al cousso d’al porco. Seilensio
Sulo sta ca∫a. Fata par veivi e par lavurà
Restada la ∫ì anca despoi de la dei∫grassia
a fa bela l’umbrì, a vardasse la cuchera
Meio monto, pai∫ de l’Eistria ch’a no iò memoria
I soin restada, crissouda par descuver∫i le ma∫ere
par no piurà anca se i vidi sicasse le fighere
Straca i me fermarè in tal’umbrì de ogno ca∫a
vula ch’a bagula ∫gourle e sempro fourbe le medi∫ime
furmeighe ch’a magari le geira cumo ch’a vuravo i altri
ma sempro le cata soun sta tera, ouna meigula
oun gran ∫bruvà, quil ch’a basta par veivi e par magnà
La casa del monte
In cima al monte una casa. Vuota // È vuota questa casa sul monte / che si rovina piano piano / col vento che le parla nella pancia vuota / spingendosi dentro per cercarla, mangiarla tutta // Fa freddo ai muri sbiaditi di fiori / che si arrampicano in fila come per ricamo / su per la riga delle scale sfasciate // Puzza di gente che non si sente più / Sul monte non c’è più neanche il letame / della vacca, il gallo che ti chiama di buonora / Scoperta anche la stalletta del porco. Silenzio // Solo questa casa. Fatta per vivere e per lavorare / È rimasta anche dopo la disgrazia / a fare bella l’ombra, a guardarsi il noce // Mio monte, paese dell’Istria che non ha memoria / Sono rimasta, cresciuta per ripulire i muriccioli di campagna / per non piangere anche se vedo i fichi seccarsi / Stanca mi fermerò all’ombra di ogni casa // dove bazzicanogrulle e sempre furbe le stesse / formiche che magari girano come vorrebbero gli altri / ma trovano sempre su questa terra, una briciola / un chicco bollito appena, quello che basta per vivere e per mangiare
Dalla raccolta Ma∫ere/Gromače/Muri a secco Book-EDIT-Durieux, Bologna/Fiume/Zagabria 1993, pp. 90-93.
Quella della Bogliun resta una delle voci più alte della letteratura italiana dell’Istria, nobile tradizione alla quale la poetessa di Dignano ha saputo dare un contributo di eccellenza, assieme a Ligio Zanini, nella variante istroromanza della sua parlata, anche se ormai, persino per un lettore familiarizzato con i dialetti, il favelà del suo dignanese produce l’impressione di avere a che fare con un fossile vivente. Peraltro, esso mantiene vistose parentele con le altre forme in volgare d’area veneta, a cominciare dal gradese di Marin, come è palesato dalla persistenza della voce «favelà» ad indicare l’atto linguistico, tanto a Grado o nell’area friulana, quanto a Dignano.
Una particolare sapidità, di conseguenza, caratterizza molte delle sue scelte lessicali come nel caso del lemma «spoussa» («puzza»), di forte impatto quanto a realismo e a taratura sulle tonalità più basse e popolari del registro, meglio ancora se venga rafforzata da figure retoriche quali la paronomasia (ad es. nella coppia «∫ento : no sento», con valore, rispettivamente, di sostantivo, per «gente», e di voce verbale nel significato di «percepire, sentire»); altrettanto vale per i lemmi «favèla» (parola, lingua), «ledàn» (letame), «cousso» (stalletta per il maiale, in associazione automatica a «spoussa»), «cuchera» (noce), «ma∫ere» (muriccioli di campagna e autentica parola chiave nella poetica della Bogliun), «fighere» (fichi), «oun gran ∫bruvà» (un chicco bollito), mentre le «scale sfassade» della terza strofa evocano da lontano un altro canto di lenta estenuazione, quello elevato sulle ultime vestigia della civiltà rurale nel contesto di una ristretta enclave sulle Prealpi venete nella «persona» di un castagno malato dal trevigiano Luciano Cecchinel, all’interno della raccolta Sanjut de stran (cfr. la voze del castegnèr cròt – la voce del castagno malato, in Singhiozzi di strame, Marsilio, Venezia 2012, pp. 39-44), nobilitando a questo modo la variante dialettale di Revine-Lago.
È il vuoto la nota dominante di questa lirica, una connotazione che torna con insistenza, assecondata dal ritmo compulsivo del metro alla maniera di Campana e da figure di ripetizione care al poeta di Marradi. Quel «Vudia» (vuota) inoltre, collocato in posizione molto forte, in ragione della maiuscola da semplice aggettivo viene ad assumere valore di nome proprio, come a precisare l’identità di quella dimora, ovvero dell’Istria intera, sintetizzandone l’essenza.
E il vuoto si diffonde, come per contagio o per osmosi, a tutto ciò che circonda(va) questa casa, dagli interni, ai fiori, agli animali da cortile, perfino al letame e addirittura alla lingua. Consustanziale al vuoto, sul piano dei simboli, è il silenzio: quello delle cose prima che degli uomini, ovvero il ricordo e la memoria di ciò che è stato e più non sarà. Ed è il poeta, pertanto, a farsi carico di questa assenza, per riportare in vita, se non proprio la casa, almeno il suo ricordo indelebile, quello di tutte le comunità dei dispersi sotto i colpi di maglio della storia: eccolo allora, come nei Sepolcri di Foscolo, rasentare l’ombra di ogni casa simile a una formica, intento a cercare le briciole per continuare a vivere. Qualcosa, infatti, permane e il poeta se ne elegge a custode: «Solo questa casa. Fatta per vivere e per lavorare / È rimasta anche dopo la disgrazia / a fare bella l’ombra, a guardarsi il noce», dove non è occasionale la chiusa di strofa sull’ombra che incombe minacciosa, come pure – con valore antifrastico – sul noce, sinonimo per suo statuto di permanenza e solidità.
Né è fortuito il dettaglio che la casa sorga sulla pietra di un monte che rappresenta l’intera terra d’Istria, a poca distanza, per inciso, dal terreno su cui Fulvio Tomizza aveva innestato mille piante d’ulivo in Momichia (si veda in proposito la testimonianza di Marco Munaro Incontro con Fulvio Tomizza, in «La Battana», A. XXXVII luglio-settembre 2000 n. 137, p. 6). Al vuoto onnipresente, corrisponde sul piano strofico e metrico il «pieno» dell’organizzazione del testo in versi ipermetri di quartine alternate a terzine, equivalenti sul piano formale alla solidità e quadratura della casa che, pur tetragona nelle sue fondazioni, conosce suo malgrado un destino di abbandono e declino alla pari dello strumento linguistico – il dialetto – cui è affidato il compito di cantarne il lamento nella forma di una solenne corale funebre. Da una tale prospettiva, e in stretta relazione alla più recente produzione della poetessa di Dignano [Par Creisto inseina imbroio (Per Cristo senza inganno), con una nota di Elis Barbalich-Geromella, Book Editore, Ro 2021, pp. 66], occorre aggiungere che la Bogliun ha consacrato se stessa e la propria poesia a vestali di una lingua e di una gente, salvando a questo modo la memoria di un mondo che non esiste più e che manifesta caratteri altrettanto simili nell’entroterra dell’Istria contadina quanto nella pedemontana veneta cantata da Cecchinel.
Sembra giungere direttamente dalla prima Cantica della Commedia il titolo della silloge summenzionata, in particolare se lo si legge in chiave antifrastica rispetto alle terzine dantesche che tratteggiano il profilo sinistro di Gerione, nel diciassettesimo dell’Inferno, incarnazione per antonomasia della frode. E forse non si è troppo lontani dal vero nel supporre che proprio la frode, nei multiformi sembianti di cui la storia ha fatto oggetto a più riprese la terra e le genti dell’Istria, sia l’oscuro signore che la poetessa tenta di esorcizzare con questa sorta di rito apotropaico in versi (l’intera silloge Par Creisto inseina imbroio, ma anche la lirica sulla casa), chiamando a raccolta le armate celesti e quelle ctonie, ovvero i luoghi e le stagioni dell’esistenza, i toponimi e i soprannomi di famiglia, i vivi come i morti, il sacro e il magico, la religiosità e la superstizione in un movimento a spirale che va dall’Istria alla Puglia passando per Friuli, Veneto e Marche, terre parimenti consacrate ai poeti che più le rappresentano, come alla stessa poesia, ma anche alla fatica, al duro lavoro della terra e alla miseria contadina di intere generazioni. Un’ulteriore chiave di lettura, e non semplicemente per questo libro, potrebbe rivelarsi l’ipotesi di una scrittura che si fa testimonianza, senza alcun risentimento e senza puntare l’indice accusatorio contro nessuno, grazie alla peculiarità di un codice che, nell’atto stesso in cui ricopre le cose di una patina arcaica e quasi fuori dal tempo, in quel preciso momento le rivela nella loro più profonda verità e sacralità, per una poetica che elegge a sommo valore la semplicità che già era cara a Saba, vale a dire le figure quotidiane del padre, della madre, della nonna, di un calzolaio, di un portico, di una vedova, di una gallina, di una luna connotata anch’essa come «contadina», ovvero di tutto quell’universo agreste che ancora ci appartiene, visceralmente intriso di cristianesimo e residui di paganesimo: «i no capeissi sto preto / ch’el par inseina cisa // mei ghe deighi a pian / lassa in pase Dignan!» (abbandono, «non capisco questo prete / che sembra senza chiesa // io gli dico piano / lascia in pace Dignano!», bandòn, in Par Creisto, cit., pp. 25 e 50) con un’eco velata, ma forte, di tante pagine di Tomizza e un’implicita denuncia delle ambiguità del clero nel complesso delle vicende istriane. Il sintagma Par Creisto, pertanto, si presta a una duplice interpretazione: assume valore di intercessione, se non di complemento di vantaggio, ma potrebbe valere anche da complemento di mezzo o di luogo nel senso di «attraverso/attraversamento», come a dire che il poeta assume su di sé il carico della propria storia e di quella collettiva quasi in un’offerta votiva, o quale necessario momento di sintesi dialettica, col risultato di attribuire ai testi, come alla realtà che essi testimoniano, l’afflato dell’epos. Per concludere, e in ragione della costitutiva polisemia di ogni testo poetico, la lirica in apertura possiede una valenza ulteriore di natura spiccatamente religiosa: il vuoto della casa, infatti, alla pari dell’ostinata fedeltà ai luoghi e alla terra da parte dell’io lirico, corrisponde sul piano simbolico alla condizione di ogni uomo che anela, senza mai conseguirla del tutto, alla ricongiunzione al divino.
Loredana Bogliun nasce a Pola nel 1955 da famiglia italiana di Dignano d’Istria. Laureata in psicologia a Lubiana, ha ultimato la specializzazione alla Facoltà di Filosofia di Zagabria.e alla Facoltà di Sociologia di Lubiana. Ha operato a Buie come psicologo scolastico, professore e preside della Scuola media superiore in lingua italiana. È stata ricercatrice nel settore della psicologia sociale presso l’Istituto di Sociologia dell’Università di Lubiana e docente al Dipartimento di Italianistica e di Scienze dell’Educazione della Facoltà di Pedagogia di Pola. Scrive in italiano e nell’idioma istroromanzo di Dignano d’Istria. Si occupa di traduzione letteraria ed ha pubblicato testi di saggistica. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia: Poesie (tradotto anche in romeno) – 1988; Ma∫ere – Muretti a secco (tradotto anche in macedone) – 1993; La trasparenza – 1996; Approdi – Antologia di Poesia – 1996; La peicia – 1997; Istrianitudini – 1997; Soun la poiana – 2000; Graspi- Grappoli – 2013; Sfisse-Fessure – 2016; Par Creisto inseina imbroio – Per Cristo senza inganno – 2021.
Mauro Sambi
Go capì
Con mi dentro de mi parlo cussì
cussì ciàcolo co’ i mii vivi e i morti
in sogno co sogno e co penso
in ti, mio dialeto de Pola, ancora
dopo ani e ani lontan de ti
mi vivo co più forte vivo e sento.
In ti no’ scrivo, no’ go savù scriver
fin ’desso, pe’ ’l tropo dolor che in ti
ga scrito, fin farte squasi morir
sbregà in due de un destin disgrassià;
e me tegnivo streto l’italian
che de lontan me diseva ‘ti son’.
Finirò, ti finirà forsi un poco
dopo de mi, ma te tocarà anche
ti; ’desso che go capì devo scriver;
perché ne ’l neverìn in ti gavemo
podù, noi pochi – più de tuto in ti –
anche goder el ben, e rider, viver.
Ho capito Con me dentro di me parlo così / così chiacchiero coi miei vivi e i morti / in sogno quando sogno e quando penso / in te, mio dialetto di Pola, ancora / dopo molti anni lontano da te / io vivo quando più intensamente vivo e sento. // In te non scrivo, non ho saputo scrivere / finora, per il troppo dolore che in te / ha scritto, fino a farti quasi morire / lacerato in due da un destino disgraziato; / e mi tenevo stretto l’italiano / che da lontano mi diceva ‘ci sei’. // Finirò, finirai forse un po’ / dopo di me, ma toccherà anche / a te; adesso che l’ho capito devo scrivere; / perché nel fortunale in te abbiamo / potuto, noi pochi – soprattutto in te – / anche godere il bene, e ridere, vivere.
Da Quel tanto nella voce, Ronzani, Vicenza 2022, p. 328.
A questa lirica delicata e toccante, interamente giocata sul ritmo ternario delle strofe, cifra emblematica della perfezione, Sambi affida il compito di rinsaldare il legame con le proprie radici istriane, in particolare con il dialetto istroveneto di Pola, e lo fa – dettaglio per niente trascurabile – all’interno del volume con cui ci consegna l’integrale della sua produzione quasi completamente in lingua. Il suo timbro è ben riconoscibile anche nel dialetto, che qui aderisce al registro stilistico del colloquio con se stessi, sulla lontana ascendenza del Petrarca nel Secretum.
È questa, indubbiamente, la maniera migliore per confrontarci con i nodi più intricati del nostro ego, così da arrivare a scioglierli. Quello del rapporto sofferto col proprio dialetto, in effetti, resta uno degli scogli più insidiosi e tormentosi per Sambi, che riconosce onestamente fin dall’inizio le proprie «inadempienze» nei confronti dell’unica lingua grazie alla quale s’è trovato nell’invidiabile condizione di comunicare ad un tempo con i vivi e con i morti, ma sempre come «in sogno» e soltanto da lontano, dopo aver allentato, senza mai reciderlo del tutto per sua fortuna, quel cordone ombelicale che lo lega, suo malgrado, a quella terra di sole di vento e di mare che è l’Istria. La chiave onirica, che si accampa nel cuore della prima sestina, non può non evocare nello scrivente un autore di radice veneta ben presente anche a Sambi, vale a dire il polesano Munaro, in particolare nella lirica All’osteria dell’Adigetto dedicata ad Eugenio Ferdinando Palmieri; ma anche Palmieri medesimo, insieme ai conterranei Zanotto e Bressan, nei versi dei quali spesso il sogno gioca un ruolo chiave. Né sarà frutto del caso che proprio a Munaro Sambi avesse destinato uno dei suoi testi più alti e impegnativi, ovvero la sestina Dal profondo passato tanto tempo (Quel tanto, cit., pp. 273-274). Ma restiamo al dialetto, del quale il poeta è il primo a riconoscere la forza e le potenzialità, benché non ne abbia mai voluto/potuto fare il proprio codice elettivo né esclusivo, preferendovi la lingua di Dante per un’infinità di ragioni che non abbiamo lo spazio per discutere qui, e nemmeno le competenze. Tale sofferta confessione s’impone di forza all’interno della sestina centrale, vero nucleo gravitazionale del testo: «In ti no’ scrivo, no’ go savù scriver / fin ’desso». È una constatazione amara, e insieme una severa e rigorosa disamina delle cause che hanno determinato tale rinuncia: su tutte, il dolore senza limiti di intere generazioni di italiani negati nel proprio diritto ad esistere e ad esprimersi nella propria lingua madre. È la stessa ferita profonda e insanabile che affligge chiunque abbia avuto radici da quella parte dell’Adriatico; Sambi vi fa i conti in questo modo e tuttavia va ribadito che non si tratta nel suo caso di una colpa, di una negligenza, di mancanza di volontà o di un difetto di talento per il dialetto; si tratta, piuttosto, di una necessità imposta dalla storia, quella delle sue genti, insieme alla sua personale vicenda di istriano che nell’italiano riconosce l’unico strumento utile a riconciliarsi, appunto, col proprio destino, impresa nella quale pochissimi hanno avuto successo, e Sambi è fra questi.
Non per questo il poeta si lascia irretire dalla tentazione di farne un nuovo assoluto, consapevole com’è sulla scorta di Brodskji della propria finitezza e di quella di tutte le cose umane, a partire proprio dal linguaggio. La via d’uscita da tali strettoie sta nel prendere atto dell’aporia risolvendosi ad utilizzare in poesia anche questo codice troppo a lungo sacrificato, giacché proprio il dialetto aveva garantito a lui come ad altri, prima o dopo di lui, gli strumenti con cui far fronte ai fortunali della storia. Con la sola precisazione che in Sambi tale codice assolve una funzione non semplicemente individuale, bensì corale, nel senso che un’intera gente vi si è venuta riconoscendo, in aggiunta al «dettaglio» che si tratta, allo stesso tempo e in pari misura, di una lingua delle madri come dei padri, nella chiara consapevolezza che l’approssimarsi alla fine, tanto per il dialetto quanto per il poeta che qui ne fa uso, non va assunto come estremo (e comunque precario) punto d’approdo, bensì quale punto di partenza di una stagione a venire che potrebbe garantire nuovi guadagni.
Una pregnanza semantica davvero singolare va riconosciuta senz’altro al lemma «neverìn», che vale a confermarci quanto risulti stratificata e complessa, alla pari di tutte le altre, la questione linguistica in terra d’Istria: dall’originaria voce «nivaria» di ascendenza veneto-latina, infatti, perso del tutto per strada il valore di tempesta di neve («nivale»), il vocabolo finiva per fondersi, filtrato dal dialetto istroveneto, con un termine equivalente di origine ciacava (un altro dialetto slavo) come diminutivo di «nevèra», ad esprimere la repentina instabilità temporalesca estiva sul mare. E non andrà sottovalutato il fatto che, nella chiusa, il poeta stabilisca un significativo parallelismo tra la vita, la gioia e il bene (piuttosto che il bello), ribadendo a questo modo l’indiscusso primato riconosciuto all’etica, prima che all’estetica, e sempre per il tramite del dialetto: «goder el ben, e rider, viver». Quanto all’«illuminazione» cui si allude nella lirica, a partire dal titolo, essa investe ambiti e orizzonti molto più vasti del fronte linguistico: abbraccia per intero l’arco di tutta la storia del secolo scorso e di quelli passati, la condizione umana nel suo complesso di ogni tempo e sotto ogni latitudine, la precarietà congenita nel nostro essere uomini attraverso il serrato confronto, su un piano extraletterario, con le contingenze di infermità e malattie, proprie o altrui.
Ed è anche per questa via, quella cioè di valorizzare al massimo il potenziale semantico delle parole o delle lingue, che il poeta di Pola testimonia quanta poca distanza lo separi dalla dimensione del sacro, pur se in proporzione inversa rispetto alla misura in cui vi si avvicina la sua conterranea Loredana Bogliun per mezzo del medesimo tramite, la lingua, ovvero il dialetto di Dignano d’Istria. Sacralità che andrà intesa in prima istanza, nel caso di Sambi, nel senso del massimo investimento, quanto a rigore e onestà, nei confronti di se stesso e del proprio lettore, prima ancora che rispetto alla lingua e alla tradizione.
Mauro Sambi (1968) è professore ordinario di Chimica generale e inorganica e di Chimica delle superfici all’Università di Padova. La sua attività scientifica riguarda lo studio della struttura e della reattività di nanosistemi bidimensionali supportati su superfici inorganiche. In quest’ambito è coautore di oltre un centinaio di articoli pubblicati su riviste internazionali. Dal 2020 è socio corrispondente residente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per la classe di Scienze Naturali. Dal 2021 dirige Padova University Press, la casa editrice dell’Università di Padova.
In parallelo all’attività professionale ha sempre coltivato interessi letterari. In quest’ambito ha pubblicato Di molte quinte vuote (Pasian di Prato, Campanotto, 1998), L’alloro di Pound (Fiume, Edit, 2009), Diario d’inverno (Faloppio, Lietocolle, 2015), Una scoperta del pensiero e altre fedeltà (Vicenza, Ronzani Editore, 2018). Quel tanto nella voce (Ronzani, 2022) raccoglie tutta la sua produzione in versi fino al 2020.
Per Ronzani Editore ha curato l’edizione dell’opera narrativa di Nelida Milani (Di sole, di vento e di mare, 2019; Cronaca delle Baracche, 3 voll., 2021), e dei romanzi Martin Muma del poeta rovignese Ligio Zanini e A Fiume, un’estate dello scrittore e giornalista fiumano Ezio Mestrovich (2022).

Lascia un commento