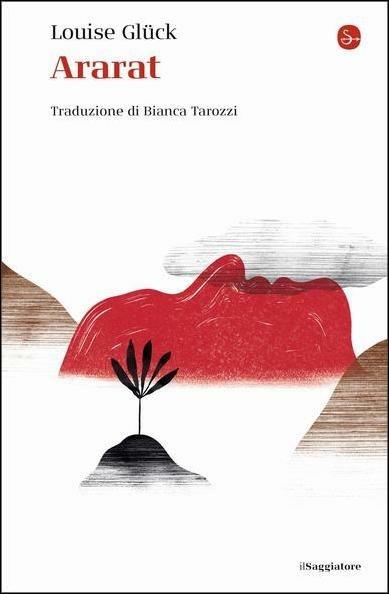
Nella poesia Un romanzo, in Ararat, Louise Glück dice che non si può “scrivere un romanzo su questa famiglia”. E vien da dire subito che è vero, anche se siamo certamente dentro una narrazione. Non c’è uno scorrimento diacronico di vicende, né un’ordinata analisi introspettiva. Tutto si mostra su un piano orizzontale, sincronico, quasi staticamente come in fotografie, su cui tagli e squarci alla Fontana progressivamente scavano i sovrapposti strati dietro-dentro l’apparenza dell’immagine, sollevando veli e mutando progressivamente qualcosa, anche minimo, nelle pose, nelle espressioni, nelle interazioni, così che, come in una sequenza di figurine mosse a fotogrammi da un’antica moviola a manovella, se da una parte si restituisce, pur minimale, il movimento della vita, dall’altra si opera un mutamento nell’apparire di ogni personaggio che arriva a una dolorosa, cruda, viscerale nudità. Il critico Dwight Garner ha detto che Ararat è: “il libro di poesia americana più brutale e più colmo di dolore pubblicato negli ultimi 25 anni”. Se c’è un’embrionale struttura narrativa, è più simile a quella delle narrazioni che puntano ad un qualche disvelamento, con sospensioni, allusioni, straniamenti, sorprese, attraverso contrasti e contraddizioni che oscillano tra il lacerante ed il lunatico, quasi a convincere il lettore che non si potrà mai raggiungere un’univoca verità. Tombe e defunti sono intrecciati alle vicende dei vivi e ai tagli della poeta narrante, mai separati nei ricordi che sostano nel presente, ma personaggi che ancora vi agiscono e turbano, sfuggendo ad una pacificazione definitoria e definitiva. Il linguaggio è prosastico, scarno, essenziale, chirurgico nella precisione dei termini, tendente all’ellissi, dove si affidano taciuti brandelli di dialoghi, pensieri, mormorii, agli spazi bianchi del silenzio tra i versi, un nondetto che ripropone una modalità dei rapporti nella famiglia. Quasi assenti le metafore, alcuni oggetti e situazioni si caricano come correlativi oggettivi di significato simbolico (i tanti tramonti che figurano ciò che va a finire, morire; il bruco che soccombe alle formiche come la normale violenza vitale, ecc.); c’è invece tanta sineddoche e metonimia, perché i personaggi non sono mai a tutto tondo, ma si mostrano e caratterizzano per parti e adiacenze che li individuano e spesso definiscono nel profondo, come i fiori che coltiva la sorella minore. Una poesia, per me (non certo per i buoni conoscitori della poesia statunitense contemporanea), del tutto nuova e potente, capace di affrontare grandi temi esistenziali e sociali attraverso l’esperienza della poeta, che ne fa materia di tutti, contro le maldicenze arrabbiate di chi puntava a ben altro Nobel: benedetti questi signori svedesi che molto spesso sanno guardare dove altri non guardano, che qualche volta azzarderanno forse molto, ma che quasi sempre aprono prospettive luminosissime. Adesso qui, vorrei parlare di Ararat seguendo passo passo – com’è peraltro mia abitudine (o vizio?) analitica – l’andamento della narrazione, anche a costo di dilungarmi molto – mio consueto difetto – perché vorrei che il raro lettore paziente potesse gustare questa straordinaria costruzione narrativa e disvelante.
“Molto tempo fa, sono stata ferita.” È assolutamente un inizio soggettivo, non solo il primo verso, ma tutta la poesia, che però si intitola Parodo, come la prima apparizione del coro nell’orchestra del teatro greco. Questo ‘io’, da subito, è corale: nonostante la sua individualissima solitudine, esiste degli allacci, delle intersezioni con tutto quanto di umano e non umano gli sta intorno nella scena, come si vedrà, e come già viene significato da quell’exergo platonico che definisce l’amore come “il desiderio e la ricerca” della metà perduta del proprio “intero” da parte di ogni essere umano, che originariamente era completo. Non so se poi Glück avesse presente anche quella ulteriore parte del mito che l’Aristofane del Simposio ricorda ai convitati, dove Zeus è costretto a fare intervenire Eros nel ricongiungimento fisico delle parti che si ritrovano, affinché gli umani si accoppino in un’unità solo fittizia e non duratura, bastante giusto per la riproduzione, in quanto, se invece si ricomponesse l’unità primordiale, le parti si lascerebbero morire di fame, nell’unico desiderio di non separarsi più. All’inizio, dunque, come una rubrica miniata dal sangue, sta una ferita. Tanto irrefutabile e ‘originale’, quanto indefinita. Precisa invece la reazione: imparare ad esistere nel distacco dal mondo, fisicamente, “out of touch”, “fuori dal contatto”. C’è un ‘io’ che identifichiamo come io-narrante (“vi dirò”), ma che si rovescia subito nel suo opposto: “volevo essere – / un congegno fatto per ascoltare”. Chi, come, perché, ancora indefiniti, se non per la modalità: “Not inert: still.” Nonostante la lapidaria secchezza, non così facile da sciogliere: “Non inerte: immobile.”. Potrebbe essere un atteggiamento di ricezione aperta, ma non passiva, se immediatamente dopo la precisazione “Un pezzo di legno. Una pietra.” non cancellasse ogni coinvolgimento. Nel silenzio successivo tra i versi, una possibile obiezione, se la ripresa che segue pare decisamente una replica per rivendicare una propria forza instancabile a opporre la propria voce. A chi? Compaiono gli altri attori, “quelli che respiravano negli altri letti”, subito lontani, apparentemente neutri, anche se quell’ “altri letti” potrebbe richiamare una vicinanza, una convivenza: comunque non “in grado di seguirmi” – definizione che inchioda tanto duramente quanto indefinita è la causazione: “incontrollabili / come lo sono i sogni”. All’impossibilità di una comunicazione, forse per una loro impermanenza che li fa imprevedibili –come la vita– si aggiunge un’inafferrabilità onirica, fantasmatica. Forse anche pericolosi, per l’incontrollabilità delle emozioni, delle risposte alle aspettative, nei rapporti con loro. Poi un’operazione di straniamento, come se una tessera a caso di un già-stato fosse caduta lì, estranea: “Attraverso le veneziane, osservavo / la luna nel cielo notturno restringersi e gonfiarsi”. Quella volontà iniziale di ascolto e nei versi a seguito quella “vocazione” a “testimoniare / i grandi misteri” parrebbero ridursi qui ad uno sbirciare a pezzi, a strisce, quasi di soppiatto, con paura, qualcosa che, sia luna o altro, goffamente si gonfia e si affloscia, come un ventre nel respiro, come la vita. Eppure, nei versi conclusivi della poesia e della sua esperienza di “nascita e morte”, dice di avere raggiunto una conoscenza: “so”. Più che il ruolo di conferma (“prove”) della reale natura della vita che “nascita e morte” mostrano senza misteri, a me pare che la consapevolezza raggiunta stia in quel “buia” senza remissione, scappatoie, speranze, riferito alla vita: “Ora che ho visto / e nascita e morte, so / che per la buia natura esse / sono prove, non / misteri –”. Nella poesia che segue ancora c’è un dire, molto più amicale: “Sai cosa ti dico?”. Si parla della morte, esperienza comune, consueta, e dei comportamenti usuali, dei rituali conformi alle regole sociali, al cimitero, nella casa del defunto, oggettivamente, osservati dall’esterno, con grande freddezza e distacco, gesti, parole, imbarazzi, come in un documentario funerario. Solo alla fine, ma sempre con un’ottica oggettiva, senza apparente partecipazione soggettiva, si entra nel desiderio celato della vedova che vorrebbe andarsene dalla confusione del ricevimento funebre, “indietro nel tempo”, anche solo al momento del cimitero o della malattia, senza la pretesa di arrivare “fino al matrimonio, non fino al primo bacio”. Impossibile, assurdo, ma è la “sola speranza”. Una follia, una fantasia (così si intitola la poesia) che esprime in modo acerbo e disperato – oggettivo – il dolore di chi resta. Anche della figlia scrivente, non solo della vedova, perché questo è il funerale del padre. Forse è per questo (e non per le ragioni che si adducono nel testo successivo: “troppi personaggi”, per di più “che si assomigliano”, e ad ulteriore complicazione, che “sono tutte donne”) che non è possibile “scrivere un romanzo su questa famiglia”, naturalmente ‘questa’ sopravvissuta al defunto del funerale precedente. E infatti immediatamente: “c’era un solo eroe. // Ora l’eroe è morto.”. Il luogo comune “le donne durano più a lungo” si qualifica con un commento pungente della voce narrante, quasi invisibile nell’oggettività della narrazione: “come echi”, naturalmente del defunto eroe, paragone che le prolunga in un’autonomia fittizia ed inutile senza il sole a cui volgersi, tanto che come in un sillogismo, si decreta che “esser tanto forti non può far loro del bene”. Come previsto, la narrazione si blocca, perché non succede niente, “non c’è trama senza eroe”: il defunto è più vitale e personaggio delle vive. Un’altra parentesi esplicativa della voce narrante introduce una grande ambiguità: in questa famiglia “quando dici trama ti riferisci a una storia d’amore”. Assenza d’amore per l’assenza dell’eroe o impossibile amore tra le sopravvissute? Di fatto le donne si muovono solo quel tanto che necessita per “le apparenze”, ma “non c’è azione, non c’è sviluppo del personaggio”. L’unico intento nella loro immobilità è il tacere, anzi il cancellare “ogni critica all’eroe” (che quindi potrebbe essere possibile) e le “scene in cui compare” – ricordi, resoconti del passato – lo mostrano nel ruolo che doveva rivestire, non nella “sua natura” di “debole”. Da notare il linguaggio che si estranea dai sentimenti per incentrarsi sull’analisi della costruzione narrativa, come un giallista che deve approntare un’investigazione: “Forse questo può spiegare come mai la sua morte non sia stata commovente.”. Viene rievocata, come in un sunto, la vicenda della morte: stava seduto “a capotavola”; qui però è subito sminuito il suo ruolo d’autorità; era lì perché occorreva una “figura” autorevole (“persona distante”, si dirà più avanti), non perché lo fosse. Poi, dopo “qualche passo” muore, “più in là” da quella posizione di non sua autorità, senza grida di spavento, pianti: se ci sono stati, sono censurati, forse per non lasciare spazio alle emozioni; è registrato freddamente solo il gesto della moglie che verifica la morte con lo “specchio davanti alla bocca”. Quasi in un’accelerazione da film muto, le donne continuano a muoversi nelle ripetitive faccende domestiche. Si precisa qui: “moglie e le due figlie”, quindi è in scena anche colei che appena dopo si mostrerà apertamente come l’io-narrante. Ecco allora, pur nella durezza di un fulmine congelato, finalmente, il dolore, anche se ancora oggettivo, impersonale, vagamente iconico: “Ogni cuore attraversato da una spada.”. Poi, proprio come in un romanzo o in un film, si dice che è passato un anno. L’io-narrante dichiara la sua appartenenza alla vicenda: “mio padre” è quel morto. Ma la narrazione non diventa soggettiva; l’entrata in scena è stata solo per informazione. L’oggettività si fa ancora più anonima: puntigliosa sul tempo caldissimo di quel funerale contrapposto al freddo di adesso, nella carrellata sulla casa, sulle “noi” – “parenti stretti” che la abitano, sulla “figlia di mia sorella” – nuova entratura – che va in bicicletta per passare il tempo, identica all’anno scorso, come un fotogramma impazzito che non procede. Per “noialtri”, invece, il tempo è già quello in corsa inarrestabile per cui “una vita intera non è nulla”. Lungi dallo scavare nell’emozione profonda di questo trascorrere, si riporta la consueta formulazione del dire comune sull’oggi bambino e vecchio un attimo dopo. Solo nell’ultimo verso, anche qui, traspare il pathos: ancora fulmineo, durissimo, impersonale, in un mulinello di metafore riguardanti la scrittura o, meglio, il parlare, in cui domina la vitalità del fiato: “Non una frase, ma un respiro, una cesura.”. Il defunto, non nominato, è più vivo che mai, nella casa che le sue donne – ma l’io-narrante pare solo registrare senza partecipare – hanno trasformato nella “sua vera tomba”. Quella del cimitero è solo un masso di granito contornato dall’erba con iscrizioni che, per pulirle della terra, “si adopera il fazzoletto”: unico particolare che, pur estraniato nell’impersonale, lascia sfuggire qualcosa di intimo, affettivo. Invece intorno alla veranda, ai gradini d’ingresso, la sorella ossessivamente pianta bulbi, aspettando i fiori a primavera. Col solito tono del comune buonsenso la voce narrante ne registra i costi, ma più che altro per mettere in luce una sorta di speciale tolleranza della madre – che paga – che sottintende una vera e propria alleanza sodale, perché poi il clima di Long Island non sarebbe adatto, e spesso un temporale, anch’esso imprevedibile e portatore di morte “da un giorno all’altro”, distrugge i fiori. Ma la madre si preoccupa solo che la figlia non possa godere della loro bellezza e soprattutto che non li viva come un rinnovarsi del dolore della perdita. Invece per la sorella accettare la perdita “è la condizione dell’amore”: “figlia di mio padre: / il volto dell’amore, per lei, / è un viso che si gira dall’altra parte”. Abituata ad una reticenza, una sottrazione che non differisce molto dalla perdita definitiva? Non sono certa, sento solo lo sguardo della sorella-narrante che è assolutamente esterna, esclusa, diversa. Altre donne di questa genia femminile emergono, tutte presenti, le vive e le morte; e la voce narrante, fuori quadro come dietro una cinepresa, che sceglie e allarga su particolari che dicono più di quanto l’oggettività non rivelerebbe. Madre e zia, in un caldo torrido che inchioda al chiuso nella parte più fresca della casa, giocano a carte: la madre stanca per non riuscire a riposarsi nel letto vuoto del marito, ma anche – precisazione sibillina – per l’abitudine che aveva preso a dormire per terra di fianco al “letto speciale” di lui che “stava morendo”. “Non riesce a concentrarsi”, ma la zia non le dà tregua, perché sono state “allevate” a non sottrarsi mai alla sfida per rispetto dell’avversario. Giocano a “Dispetto e Malizia”, il passatempo di famiglia, come gliel’ha insegnato “mia nonna”, “previdente” nel preparare le figlie a farsi bastare la propria compagnia. Nonostante la precisione dello sguardo sulle carte nel gioco, resta l’impressione di una dura metafora di relazioni: “è un gioco migliore degli altri, meglio di un solitario”. Di nuovo pare di essere in un’immobilità ripetitiva senza fine. Invece “d’un tratto, qualcosa finisce”, è il tramonto e questo è ciò che significa oggettivamente per la voce narrante. La zia “è più brava”, resta senza carte – “evaporano”, come “deve essere”, perché “quella che non ha niente vince”. Forse qui si annida un giudizio che affonda come una coltellata. Infine non può mancare lei, la voce narrante, che dalla Confessione diventa personaggio ed un vero io-narrante. In questo ‘a-parte’ vengono esibite in primis le paure, affiancate da sogni che subito sono messi da parte, non per proteggersi dalla delusione della mancata realizzazione, ma invece proprio per la paura del loro “compimento”, che è la paura della perdita, in quanto le Parche della vita, non a caso qui definite nel loro essere “sorelle, selvagge”, agiscono solo sulla spinta della “loro unica / emozione” che è “l’invidia”, anticipazione del collante di ben altra coppia sororale. A questo punto non poteva più restare fuori la sorella “che morì”, quasi misteriosamente, perché “non voleva essere nutrita”, pur essendo tra le braccia della madre. È un’osservazione che sembrerebbe di una bambina, della sorella nata dopo, che quelle braccia d’affetto non trova più, ma un cuore divenuto “molto freddo, molto rigido / come un minuscolo pendaglio di ferro”, attirato inesorabilmente dal “magnete” del “corpo” – non cadavere, si noti – della sorella, che “così sarebbe cresciuto”. La madre, forse proprio per tutti quei preparativi, sogni, progetti, profusi nell’attesa della sua prima creatura, forse proprio perché arrivò a sfiorare per la prima volta la morte nella sua primogenita, non riuscì a tenersi il cuore caldo per le figlie che sarebbero venute dopo. Adesso è “esperta” nel “mandare la gente che ama all’altro mondo”. Adesso sa come cullare, sussurrare o cantare a bassa voce per vivi e moribondi; d’altra parte le “ninnenanne”, che esortano contro la paura, “parafrasando / il battito del cuore della madre”, vanno bene sia per il sonno che per la morte. Ed ecco un colpo di lama inatteso in questa idilliaca consolazione: sono “i viventi” a calmarsi, si obietta, perché ai “morenti” non è possibile, rifiutano di andarsene quietamente. Anche se sembrano fermi e interi, “sono come trottole” che “roteano così rapidi” da non farlo vedere, fino a volarsene via; la sorella nelle braccia della madre era solo “una nuvola di atomi, di particelle”, mentre “un bambino che dorme, è ancora intero”. La madre, infatti, dopo averla vista la morte, “il buio” che “cresceva / solidamente intorno” fino a diventare “terra”, non parla dell’“anima” come potesse restare intera. È l’io-narrante di radice ebraica che conclude questo tema metafisico, come si trattasse di buon senso comune: perché mai l’anima, di “materia” anch’essa, dovrebbe mantenersi “fedele a una sola forma / quando potrebbe essere libera?”. È qui che si erge di colpo il Monte Ararat, che è anche il nome di un cimitero di Long Island, ma che credo stia a significare di più per la poeta, se anche al figlio ha dato il nome di Noah. Madre e zia hanno entrambe perso una figlia, le cui tombe stanno una di fianco all’altra in quel cimitero, che dovrebbe portare nel nome il ricordo di una pacificazione con Dio dopo il diluvio. Ma il dolore di queste madri è tale che l’io-narrante, definitivamente coinvolto nella vicenda, ne distoglie la vista – rapporto col dolore che, vedremo, le è proprio. Non può comunque non partecipare a quell’aura fatalistica della famiglia che sente come un “destino” le morti di figlie femmine, al punto che la “generazione” successiva ha ritardato matrimonio e figli. Maschi, per lo più, i figli. Al punto che è “un “sollievo seppellire un adulto”, anche se è “mio padre”. Come se si fosse “pagato” il “debito”. Ma “in realtà nessuno lo crede” veramente, perché lì tutto della “terra”, “ogni pietra”, è consacrata “al dio ebreo / che non esita a strappare / un figlio alla madre”. Il dio che fece approdare l’Arca sul Monte Ararat, circondato da ogni parte da un immenso mare di uccisi dal diluvio. Noah, il giusto, scampato alla strage, forse per la poeta è soprattutto segno propiziatorio contro la maledizione di famiglia. Ora che è entrato nella vicenda, l’io-narrante può dire del rapporto con la madre e con la sorella minore. Opposte nel colore dei capelli – la “bruna” maggiore sta guardando i due ritratti che i genitori fecero fare a Parigi – come nel piacere di parlare, anche se in quel tempo la più piccola “ha un’aria arrabbiata” perché ancora non ci riesce. Nulla è cambiato da adulte, nonostante l’analisi e il sapere decifrare le “espressioni”. La madre, proprio per sottolineare che erano sorelle, le ha sempre vestite uguali come nei ritratti, ma quelli furono poi appesi sopra il caminetto, ben separati, in modo che gli occhi fissassero il vuoto e non fossero in competizione fra loro. L’immobilità di quelle pose parigine, l’io-narrante ricorda che la sopportava bene, per dimostrare di “essere buona” e “far piacere a mia madre, per distrarla dalla bambina che era morta”. Per fermarsi alla sua attenzione, era disposta ad un’immobilità ubbidiente, come un giocattolo meccanico, L’immobilità anche nel suo voler restare bambina, perché sua madre, come la nonna prima di lei, non concepiva l’impermanenza, il cambiamento che turba l’ordine, stava bene nella consuetudine prevedibile e sicura. Continuava ad amare la “bambina morta” – ci riescono tutti ad amare “un’assenza”, è il commento sibillino dell’io-narrante –, ma le due figlie “vive”, non riusciva tutt’e due insieme, senza “cancellare / una”: se ne amava una, “danneggiava l’altra”. Dove quest’“altra” è certo una delle due presenti, ma anche la morta. Non poteva diversamente la madre, “altrimenti si sarebbe spezzata in due”. Solo il pittore l’aveva notato e portato nel ritratto, quel viso della bimba bruna “già così controllato, così chiuso / e troppo obbediente”, i cui occhi dicevano: “Se vuoi che io sia una suora, sarò una suora.”. È quasi logico questo altro ‘a-parte’ in cui l’io-narrante si sviscera. Come sul lettino dello psichiatra, contraddittoriamente si apre, svela e insieme implora di non essere creduta, soprattutto se si lascia trasportare dalle emozioni, perché la “ferita al cuore” le ha colpito anche la “mente”. È distruttiva verso se stessa: “sprecate”, inutili, quell’intelligenza e abilità con la lingua di cui la lodano, se non riesce a vedersi per mano a sua sorella, se non sa da dove vengano quei “lividi” sul polso di lei. Non è generosa come potrebbe sembrare, è “bugiarda”, “invisibile”, perciò “pericolosa”. Per arrivare alla “verità”, sa che dovrebbe essere cancellato proprio il suo essere stata “figlia maggiore”, in quella “casetta” contornata d’azzurro e nuvole bianche, ma “grigia”, accesa solo delle “azalee rosse e rosa”, che noi sappiamo segno metonimico della sorella. La verità può trovarsi allora nel racconto biblico della decisione di Salomone di tagliare in due il figlio conteso da due madri per capire, dalla sua rinuncia per salvare il bambino, quale fosse l’autentica. Così la madre, la si potrebbe considerare “divisa tra due figlie”, tale che, per salvarla, una delle due dovrebbe essere disposta a “distruggere se stessa”: la madre, allora, “capirebbe / quale bambina è la sua, / quella che non può sopportare / di dividere la madre”. Espressione che si adatta al sacrificio biblico, ma anche ribadisce il male di base dell’io narrante, venuto alla luce: la rivalità per l’amore materno con la sorella. Mai una volta, in tutta la raccolta la madre è altro che “mia”. Ora, comunque, è possibile parlarne nel suo rapporto col fedele comprimario, il padre – anche lui sempre “mio”, così come “miei” i genitori. L’io-narrante l’ha vista sempre “sottomessa, come avesse del piombo / legato attorno alle caviglie”. I loro gusti, desideri, modalità di vita erano opposti, ma, come norma del conformismo corrente, era “la persona attiva”, quindi la madre, a dover cedere per permettere l’uniformità di coppia. La morte del marito sembra averla liberata: viaggi, mostre, ma è solo apparenza. È rimasta “sospesa per aria”, “come il palloncino” sfuggito a un bambino, o “un astronauta / (…) alla deriva nello spazio”. Perché sa che, comunque si prolunghi ancora il tempo della vita, è un tempo da vivere che “resta”. Diremmo noi, in aggiunta: i giochi ormai sono stati giocati. Libera sì, allora, ma dal “rapporto con la terra”. Ed ecco una vicenda che la riguarda. Un suo “vecchio ammiratore” per ogni compleanno le mandava dodici rose, che per dieci anni continuarono ad arrivare anche dopo che lui era morto, quasi a confermare “la leggenda” della sua “bellezza” anche da “sottoterra”. La famiglia lo aveva accettato e si era abituata a questo segno “di cortesia, di generosità”; addirittura l’io narrante pensava che le rose fossero un modo dei morti di confortare ancora i vivi. Non capiva che si trattava di “un’anomalia”, perché in realtà “i morti erano come mio padre”. Comunque sua madre “non ha bisogno / di dimostrazioni da parte di mio padre”: passa il suo compleanno sulla tomba di lui, a dimostrare “che capisce / che accetta”, e poi lui non ama “gli inganni” e lei – arriva la sciabolata! – “non vuole / segni di affetto da chi è incapace di sentire.”. Oggi la madre non capisce come lei, così critica verso la famiglia, abbia potuto farsene una. Non le risponde mai, ma il motivo le è ben chiaro: da bambina detestava “non poter scegliere / le persone da amare”. Poi rivolge l’occhio analitico al rapporto col figlio, nuovo personaggio: se si era ripromessa un amore rispettoso della sua autonomia e senza possessività, invece si scopre in atteggiamenti di ossessiva attenzione a lui, più o meno come faceva sua madre con lei. Allora l’impegno è di “imparare / a perdonare mia madre, / ora che non riesco / a risparmiare mio figlio”. Quando legge inquieto il sonno del figlio – “le tue palpebre tremano” – ne sente la responsabilità, come se il temere, il “diffidare” venisse ereditariamente da lei. Ma non vuole conoscere i suoi sogni e pensieri, non capisce come una madre possa pretendere “l’anima” del figlio; lei pure ha fatto quest’errore in passato per amore, ma mai con lui, nemmeno da piccolo: “Eri nato, eri lontano.”. Lasciava che i pianti venissero e passassero, indipendenti da lei, senza doverli significare. “L’anima è silenziosa.”, misteriosa, indecifrabile, se non qualche volta “nei sogni”. Si apre quindi, quasi un prolungamento del rapporto tra le due sorelle, il confronto tra i loro figli. È preso a modello un coriandolo della vita cittadina: la necessità di andare a prendere i bambini che arrivano da scuola col bus, per evitare rischi e pericoli non immaginari. La figlia della sorella, come molti altri bambini, vorrebbe “tornare a casa da sola”, si sente “abbastanza grande”. La madre le concede al massimo di non tenerla per mano. È un “compromesso”, ma così la bambina ha “una mano / completamente libera”. La ritorsione però è subitanea: se è “abbastanza grande per camminare così, è anche abbastanza grande / per portare il violino”. In parallelo il tragitto verso casa del figlio della maggiore. Non parla, a testa bassa, sguardo a terra: vuole mostrarle così la “sua infelicità”. Poi “saluta il gatto”, per mostrare che sa avere un affetto, purché libero, proprio come faceva suo padre col cane. Tra lei e suo figlio il silenzio è giostrato con la più grande abilità del mondo. E tutto si confonde nei mulinelli di neve, oggettivissimi, ma anche liberi da direzioni prefissate, ribelli, imprevedibili, vivi, in netto contrasto con figlio e madre. Quasi in contrappasso precipita l’eccessivo lasciarsi parlare della sorella, che prima o poi arriva a dire quel che sente, bello o orribile che sia, e lo dice tutto in una volta, anche in “una stessa notte”. È difficile entrarci dentro, ma è possibile usare “la parola promessa”, coniugandola a “pazienza” e capacità di “aspettare, di ascoltare”. Doti che la nipote ha, per le quali sa di potere ottenere tutto. Sembra che la diversità oppositiva delle due sorelle sia passata ai figli. Lui è “in equilibrio”, non gli piace la competizione; lei, invece, è sempre in movimento, “si allena sempre”, così che il cugino “non vuole giocare con lei”; lei non si offende, per lei “chi non gioca è perché non vuole perdere”, ed “è abituata a giocare da sola”; lui non è “un inetto”, nelle corse è subito in testa, “senza sforzo”, ma “poi si ferma”: non vuole “la solitudine del vincitore”. Sua cugina, invece, prima o no che arrivi, “è sola comunque”. A guardare la nipote, “così simile a lei”, alla sorella, tornano quegli impulsi che la maggiore aveva da bambina, e di cui si vergogna: ma il desiderio di “distruggere / una vita più piccola, dipendente” è sbagliato, senza giustificazioni. Anche da bambina in qualche modo ne era consapevole, tanto che “dovevo / far male a me stessa”. E questo è un segno certo di malessere psichico. Erano considerate in effetti agli antipodi le sorelle: quella bionda, “come un sole, come una gialla dalia”; ma sui “capelli d’oro” scatta la sciabolata: “come pugnali intorno al viso”, anche se poi sotto, secondo me più ironicamente che sinceramente, la sorella dice che si vergogna di essere arrivata ad odiare le dalie. “L’altra”, lei, invece “diversa, negativa”. Sembra quasi che la rivalità sia inserita in una legge universale (o del conformismo corrente: “non è così?”): “due cose” vengono sempre messe a confronto, perché “una deve essere la migliore”. Il fatto è che “entrambe lo pensavamo”. Eppure, anche se opposte “come il giorno e la notte”, erano “un unico atto della creazione”, e lei, l’io narrante, non riusciva “a separare / le due metà”. Le due sorelle concordano oggi che “il modo migliore / di amarci” sarebbe stato quello di “non stare insieme a noi”. Infatti piacevano agli “estranei” a cui si presentavano “ben vestite, bene / educate”, mentre nell’intimità famigliare litigavano sempre, anche con danni fisici; i genitori erano ritrosi a punire direttamente, quindi si erano inventati il ‘tribunale’: era proprio la bambina più “nel torto” che sceglieva come punirsi. Non è difficile collegare questa modalità alla normale abitudine dell’io narrante di infliggersi delle ferite per sensi di colpa coscienti e inconsapevoli. Ma questa modalità educativa portò anche ad un altro sbocco: le due sorelle non riuscirono mai a “diventare alleate” per una normale “ribellione ai genitori”; era loro più naturale pensare “che eravamo / in troppi / per sopravvivere”, “come animali” a “spartirsi” l’unico “magro pascolo”, a sorvegliarsi continuamente, anche se poi “nessuna di noi due toccava / quell’unica cosa che avrebbe potuto / nutrire sua sorella”, il pieno amore, cioè, dei genitori. Quando la più piccola ancora non camminava bene e la madre “la legava al passeggino” per andare insieme a prenderla, l’altra più grande, da scuola; lei le scorgeva fin da lontano, ma andava loro incontro a passi lenti, perché “sembrasse che non aveva bisogno di niente”. La sorellina la “invidiava”, la vedeva libera, autonoma, perché ancora “non sapeva / che si può mentire con il viso, con il corpo”, e che lei, la maggiore, invidiava proprio il passeggino: questo scambio è durato per tutta la vita. Già allora l’io narrante sentiva lo spreco di “tutti gli sforzi / di mia madre” – tenere salda la sorellina, “chiamare”, “sbracciarsi” – perché “io non avevo più una casa”. Anche verso la casa di famiglia, infatti, dove ancora abita la madre, “tutta sola”, con la televisione, le due sorelle hanno un diverso atteggiamento. L’io-narrante, tornato all’oggettività, descrive un mutamento urbanistico comune; all’inizio il paese, che lei ha conosciuto, sembrava un posto idilliaco dove “metter su famiglia”: “semplice”, adatto ai bambini, “aria pulita”, impressione di campagna per “una piccola stalla” vicina. Poi pian piano è diventato “quasi una città”: case fitte e “vecchi alberi” che muoiono “o sono abbattuti”. Il cimitero dov’è la pietra col nome del padre non è lontano, e comunque la sorella continua a prendersi cura del giardino intorno alla casa – non era la sua vera tomba? A sua sorella sembra di stare in campagna, lì: prati segati, tanti fiori… “Non sa com’era un tempo.”. Silenzio tra i versi. “Ma io lo so. Come Adamo, / io ero nata prima. / Credimi, non si guarisce mai, / non si dimentica mai il dolore al fianco, / nel punto dove qualcosa è stato tolto / per fare un’altra persona.”. Quanta apparente diversità da quell’accettazione quasi biblica – Giobbe docet – della zia! Santa di famiglia insieme alla “nonna”. La zia, pur sommersa da continue disgrazie, lungi dal paragonarsi vittima rispetto alla ben più fortunata “nonna”, non incrimina nessuno del “male”. La vita – “il mare” – “è quel che è: / dove tocca terra, deve ricorrere alla violenza”. Questa visione non certo positiva della vita andrà a congiungersi con la personale vicenda dell’io-narrante nella formazione di un dolore quasi mortale e nella costituzione di un pessimismo senza requie. In cui si annida anche una percezione desolata di qualcosa che finisce, dentro un giorno dorato di fine estate, alla fine della “stagione della crescita”, nella cesura “tra quel che muore e quel che sta per sbocciare”: “ci stiamo estinguendo”, come amazzoni, “mia sorella e io, siamo la fine di qualcosa”. Infatti il “nome” di famiglia non ci sarà più, come “una lingua morta” che “non c’è bisogno di parlarla”. I figli stanno disegnando, perché è arrivato il buio, come facevano le due sorelle, ma con “soffici gessetti”, loro, che si cancellavano con niente. Un’amica dell’io narrante, credente in un dio con cui “parla”, colta, “non stupida”, coraggiosa nell’affrontare ogni problema, la stimola ad affidarsi alla fede, per superare la sua negatività verso la vita e il conseguente sottrarsene. Lei, però, anche in sogno non riesce a sentire, vedere quello che l’amica le suggerisce in alto, anzi la scopre “intrappolata in una rete” che àncora a terra. Davanti a “un bruco morente nella polvere, aggredito da avide formiche”, mentre lei si commuove, come sempre davanti alla “debolezza”, al male, e non sopporta, sottrae gli occhi; l’amica, che avrebbe potuto “osservare” neutra quell’evento solo naturale, per amor suo, sottrae “quella povera cosa” alle formiche e la posa più in là, ormai senza vita. Poi loro due restano in silenzio a guardare il tramonto: entrambe sono a loro “agio con la morte, con la solitudine” e vorrebbero capirne il senso. Poi arriva il buio, con quella “quiete che entrambe amiamo”. L’io narrante sigilla il momento ancora con un’affermazione apodittica: “L’amore per la forma è un amore per i finali.”. Come si evidenzia nei tramonti. Forse per questo “amore per i finali”, le ultime poesie sono tutte col padre. Con cui si identifica come immagine “nella buia finestra” (in un tramonto, per l’appunto, forse), ma forse anche per quel suo aver vissuto “pensando alla morte”, tanto da avere potuto facilmente rinunciare alla sua vita, che “non conteneva nulla”. Da questa certezza neanche sua moglie poteva distoglierlo, “perché era convinto / che se non puoi più amare un altro essere umano / non hai più un posto in questo mondo”. Durissimo, questo che suona come un epitaffio. Confermato dalle poesie che precedono. Prima un ricordo che pare casuale, che pare di grande intimità affettiva – il padre la porta sulle spalle al circo – se l’immagine non fosse subito invalidata dall’ambientazione: “vento freddo: / brandelli di carta bianca / svolazzavano”; e poi dalla sciabolata dolorosissima: a lui “piaceva / (…) tenermi / in modo da non potermi vedere”. Non ricorda calore d’affetto, ma solo che, guardando diritto davanti a sé quello che lui vedeva, “stavo imparando / ad assorbire quel vuoto”, riempito solo da una neve offuscante, “fitta”, che “non cadeva, faceva mulinelli intorno a noi”. Si somigliavano loro due, anche nell’abitudine di parlarsi con pochissime parole, incapaci di comunicare tra loro, tanto che erano imbarazzati a “restare soli insieme”. Ma quella che fu l’ultima volta in cui lei lo vide, fu subito chiaro che c’era una necessità insuperabile. L’“occasione speciale” era che lui stava morendo. Una ridda di particolari oggettivi sulle condizioni metereologiche, le auto per strada, il furgone del giardiniere, l’ora del giorno, i vicini, sembra quasi volere dilazionare più il là – o denunciarla indirettamente, come qualcuno che si guarda ossessivamente intorno per sottrarsi ad un grande disagio – l’emozione forte durante quello che il padre le disse: “come ci si sente quando si muore / (…) che non soffriva. / (…) che si aspettava continuamente di soffrire, aspettava il dolore, / ma non arrivava mai”. La risposta laconica di lei, “che ero contenta per lui, che pensavo fosse fortunato” è una fuga. Come le famiglie dei vicini si salutavano consuete e certe del ritorno, loro due si salutarono “nel solito modo, / senza un abbraccio, niente di drammatico”. Quando lei fu per partire col taxi, i genitori “a braccetto” stavano a guardare dalla porta come sempre, la madre lanciando baci per muovere le mani. Quella volta, però, suo padre “fece un gesto di saluto”. E lei rispose. “Come lui (…) per nascondere il tremore della mano.”. Ritorna quindi il funerale, con l’io-narrante dentro, però, attenta a cogliere ciò che l’apparenza conformistica nasconde. Gli amici del padre intervenuti, in genere in disaccordo tra loro, sembrano provare un coro sullo “stesso spartito”, per definire il defunto nel migliore dei modi, ma “senza armonia”. Almeno “versano vere lacrime”. La battuta della figlia – “Per fortuna sei morto, altrimenti / saresti sopraffatto dal disgusto.” – più che sarcastica, mi pare straniante per frenare l’emozione. Quando, infatti, quella che appare solo una ritualità rigida ed esteriore – “ortodossia” – va a finire, e negli ultimi convenevoli i “viventi” si salutano con abbracci, “spettegolano un poco”, “gli scialli delle donne” mossi dal vento della sera, emerge qualcosa che ribalta tutto: “è allora che senti / il morso dell’invidia”, perché “questo, questo è il significato di / ‘una vita fortunata’ / esistere nel presente”. L’io narrante adesso può chiudere il cerchio, tornare all’inizio. Con le stesse parole iniziali, ma tutte d’un fiato, senza virgola, quasi sospendendo la ferita da un preciso tempo passato, per estenderla ad un tempo che non ha collocazione, né termine. Adesso che la ferita aperta si lascia leggere con chiarezza. Se qui si nomina il padre, non significa che madre e sorelle non entrino appieno in questo vulnus, ma solo che con loro i conti sono già stati fatti nelle poesie precedenti. In qualche modo, però, qui il padre le riassume. E lei le riassume in quella sua vita intera “vissuta / per vendicarmi / contro mio padre”. Che è già terribile, ma il coltello affonda ancora di più: “non / per quel che era – “, quanto invece “per quello che ero io”. La colpa è sua. Tornano qui tutti insieme gli accenni apparsi in varie parti del libro sulla necessità di farsi del male, di pagare per le sue esigenze verso di loro. Ma qui si aggiunge qualcosa che toglie il fiato. Se “da bambina, pensavo / che il dolore volesse dire / che non ero amata”, e che, forse, era lei che mancava verso di loro, che non era abbastanza, che non era come avrebbe dovuto per meritare il loro amore; invece adesso è arrivata al fondo della ferita: “Voleva dire che amavo.”. E amare è un rischio, un darsi senza garanzie, pericoloso fino alla morte. Una verità che ci annichilisce. E lei, la schianta, perché ancora per lei la salvezza è lontana, nonostante anni e anni d’introspezione e meditazione. È anche una chiusa inaspettata, perché un lietofine – personalmente molto consolatoria sarebbe stata la redenzione di un ‘perdono’ – avrebbe rasserenato e rassicurato il lettore, distogliendolo dai problemi proposti e anche forse da una figuretta tutta pizzicotti e invidia che gli sta accanto in casa. Sono versi infatti che ci riguardano. Ma che non si fermano lì. Io, nel silenzio in cui si aprono, voglio convincermi di sentire un mormorio di Louise Glück che ci dice di non smettere l’amore, ma di provare a farlo diventare, da inerte, contagioso.

Lascia un commento