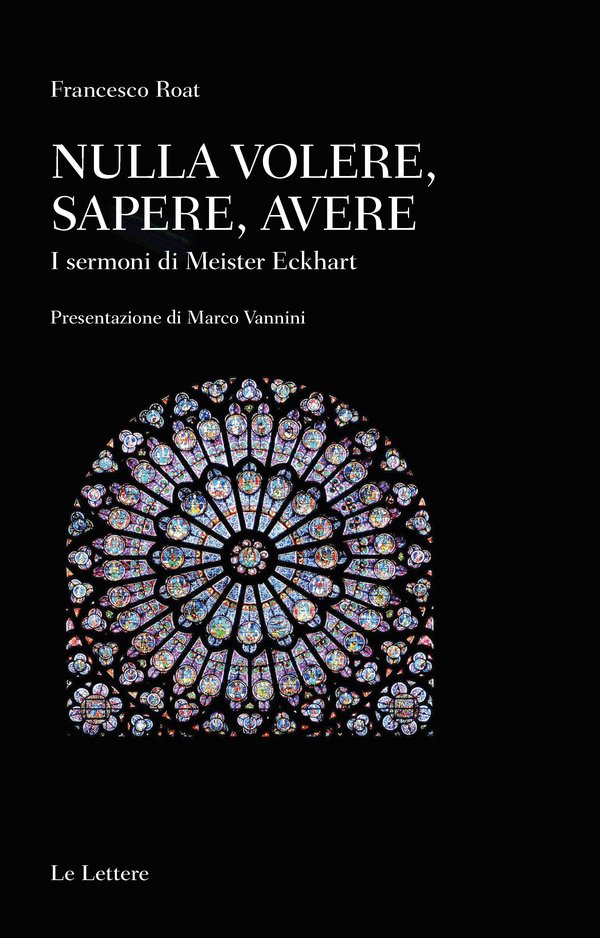

È un saggio prezioso. Non solo per l’importante riflessione di Francesco Roat sui Sermoni in volgare alto-tedesco di uno dei mistici medioevali più interessanti (1260-1327), coevo di Dante (1265-1321) e di Margherita Porete (1250-1310, di cui forse conobbe Lo specchio delle anime semplici), ma altrettanto per la ricchezza dell’apparato argomentativo, che si muove attraverso un’attenzione glottologica di precisione quasi chirurgica e in continuo riferimento ad autori antichi e moderni connessi ai testi in esame.
I più di cento Sermoni sono analizzati nei loro punti salienti, quasi singolarmente per ogni capitolo i più significativi; l’autore, poi, quando si assume la responsabilità di tralasciarne qualcuno, motiva puntualmente la propria scelta, dettata da ragioni criticamente opportune. Mai, infatti, Roat pecca di frettolosa premura nell’analisi: anche là dove potrebbe riassumere in alcune linee fondamentali un punto del pensiero di Eckart, indugia invece in una ‘lentezza’ analitica che non sdegna di ripercorrere passi che potrebbero, a una prima lettura, sembrare reiterazioni di medesimi o similari concetti, in realtà mettendo in evidenza, con uno sguardo da microscopio, nuove emergenze che, in progressiva approssimazione, portano a una complessità talmente ricca del pensiero di Meister Eckhart che non solo fanno sentire le premesse di partenza limitate e quasi monche, ma lo rendono incredibilmente attuale, moderno, vicinissimo alla nostra sensibilità e, soprattutto, ai nostri bisogni umani, esistenziali, etici. Naturalmente quest’ultimo carattere è indotto anche dal continuo relazionarsi di Roat col pensiero del Meister e con pensatori delle più diverse discipline – da Agostino a teologi contemporanei, da Plotino a Heidegger, Nietzche, Morin, Fromm, da esperti del Buddhismo, del Tao, dello Zen a Capitini – che chiama a confronto senza alcuna velleità di sincretismo, non solo per allargare il ventaglio interpretativo della riflessione eckhartiana, ma per attualizzarla, o meglio: per ‘tradurla’ alle tematiche, alle domande, alle ricerche di oggi, laddove potrebbero restare implicite nel testo tardo medioevale; senza peraltro mai forzarne l’interpretazione, ma accostando i pensieri con cautela – anche solo limitandosi ad una prossimità lineare –, col fine comunque di ‘fare relazione’, magari soltanto per una concettualità limitrofa o per una tensione a domande adiacenti. Ne risulta un apparato critico tanto attento all’oggetto specifico, quanto stimolante ad un’apertura complessa della riflessione.
Ad esempio, citando l’agape giovannea nell’Introduzione, Roat non si limita a proporne l’equivalenza con l’italiano “Amore”, ma richiama a suo completamento l’ultimo verso della Commedia di Dante (“l’amor che move il sole e l’altre stelle”), precisando che “Amore esprime relazione, rapporto, scambio, possibilità di crescita, di vita.”, inoltre citando quasi alla lettera, pur senza nominarlo, Aldo Capitini: “Qualora manchi l’apporto altruistico di un tu non si darà mai alcun io”. E già siamo portati in un ambito di riflessione che dal contesto religioso-testuale allude ad orizzonti esistenziali e culturali particolarmente attuali nel nostro drammatico presente. Come la necessità di un radicale cambio di paradigma, che sostituisca alla concezione dell’uomo padrone-predatore dell’universo, quella dell’interconnessione tra tutti i viventi, o meglio: gli esistenti, intesa non solo quale rispetto dell’altro, senza distinzione di gradi, ma come consapevolezza del suo necessario apporto al proprio esistere. Consapevolezza che non può coesistere con l’attuale sistema globale delle disuguaglianze, delle discriminazioni, delle sopraffazioni. Un cambio di paradigma che pensatori, scienziati di ogni settore, sociologi, filosofi, teologi, intellettuali, e persone comuni, sempre più spesso indicano come unica possibilità di salvezza dall’Antropocene. Anche se Roat non affronta direttamente la questione, essa emerge indirettamente, in più punti, anche qui, nel suo itinerarium in mentis Meister Eckhart, quando, ad esempio, a questo tema dell’amore convoca i risultati più recenti della fisica inerenti “la forza attrattiva che si esercita tra tutti i corpi dell’universo”. Infatti
“Ogni ambito della realtà è relazione. (…) Potremmo dire persino che si dà solo un esserci relazionale, (…) essendo l’interazione necessaria all’esistere. (…) Se chiamiamo Dio questa modalità/possibilità dell’essere, questa potenza organizzatrice, la si può cogliere come amore, come condizione o evenienza di sviluppo, vita, evoluzione, creatività intelligente”. p.11-12
E, citando Edgar Morin, ipotizza
“un livello invisibile permanente di prerealtà, infrarealtà o surrealtà co-presente al nostro universo, che per il buddhismo, sotto il nome di vacuità, è la realtà suprema, o nirvana, e, per noi, ciò che sfugge alla realtà ma fonda la realtà.” p.12
Se la scienza è, dice il qui citato Amedeo Baldi, sostanzialmente “un processo di esplorazione della realtà”, Roat conclude:
“l’origine (la creazione?) dell’universo e l’universo stesso con tutte le sue galassie, la materia visibile e quella oscura, l’antimateria, l’energia in tutte le sue forme (…) finisce con l’apparirci un mistero (…) chiamato Dio (…) [o n.d.r] caso”. (p.13)
Agli ampi brani dai Sermoni presi in esame Roat affianca, per i gruppi semantici più significativi, quando non parola per parola, l’equivalente del testo originale in volgare tedesco alto medioevale. Oltre a rendere trasparenti le scelte della traduzione, viene evidenziata la difficoltà insita nella distanza temporale tra le due lingue (e tra i sottesi contesti di conoscenze), che può comportare oggettivamente scambio o fraintendimento concettuale, non solo per la trasposizione da una concezione del mondo ad un’altra, ma soprattutto per la grande differenza quantitativa e qualitativa dei termini che veicolano i concetti-cardine nelle due lingue. Non a caso, infatti, Roat si ferma spesso a precisare in modo più ampio di una semplice proposta lessicale il significato originale del termine in questione. Scelta rigorosa e più d’una volta illuminante, per lettori, soprattutto, come me, non specialisti della materia e magari indotti dal consumo/abuso rituale/istituzionale di certi termini a non vagliarne il senso originario e a non recuperarne un significato meno banale e meno univocamente determinato. Così, ad esempio:
“Il vocabolo italiano Dio deriva dall’affine latino Deus, proveniente dalla radice indoeuropea div-, che significa splendere/brillare. Così Dio è luce all’uomo e al mondo. In tedesco, invece, Dio è chiamato Gott (per il medioevale Eckhart: got) – somigliante all’inglese God e a tanti altri termini consimili nelle varie lingue germaniche –: termine che probabilmente trae origine dall’indoeuropeo ghuto-/ghou- (chiamato), a sua volta derivante dalla radice gheu-, che significa chiamare/invocare. Dio è dunque l’invocato per antonomasia.” p.14
La scansione etimologica non è un’occorrenza solo relativa alla traduzione, ma interviene anche nei nodi dell’argomentazione, per offrire scavo e complessità, in uno sforzo, direi proprio: una ‘fatica’, che rivelano una sorta di bisogno, di quête, di ‘passione’ (in tutti i sensi del termine) di Roat verso un’almeno-approssimazione al senso dell’esistere. Si veda, ad esempio, di fronte alla difficilmente accettabile accettazione, “con soddisfazione” e come “meglio”, di “qualunque cosa” venga da Dio, anche massimamente dolorosa, fino a sentirne “soddisfazione quanto in un gran piacere”, auspicata da Eckhart (Sermone 4 §2), la riflessione di Roat intorno e attraverso la parola ‘felicità’:
“riconducibile al greco fyo (genero, faccio essere), (…) trae origine dal prefisso indoeuropeo fe che indicava generatività e vita, da cui termini italiani come feto, fertile, fecondo/a, femmina. Dunque felicità non come sinonimo di mera soddisfazione egocentrata, monadica, irrelata, ma indice di rapporto amorevole, crescita, rinnovamento vitale, rinascita (anche spirituale).” (nota10, pp.35-6)
La durezza della pratica del “distacco” dalle cose mondane diventa, da “coattiva/normativa”, affettiva e creativa. Da qui, lungi dallo scadere nel sospetto di “masochismo”, Roat ipotizza la necessità di porsi in “una sensibilità altra”, che implichi la “rinuncia” alla “pretesa” che le cose siano comunque in favore del proprio interesse, imparando ad accoglierle “tutte”. Se l’autore, in questo punto, si rivolge ad una densa pagina di Simone Weil, che riflette sul “grido” d’abbandono di Cristo in croce al Padre, personalmente sono sospinta ai diari di Etty Hillesum e Carla Simons, dove le davvero tragiche vicende del loro vivere non le riducono mai a una disperazione annichilente, e non impediscono loro di continuare a coltivare la vita nei sentimenti, nelle emozioni, nei rapporti, nelle opere concrete di sostegno agli altri.
Altri strumenti stilistici dell’analisi critica di Roat sono: l’uso molto frequente di concetti adiacenti correlati da una barra che li propone separati e sinonimi, sempre nella funzione di rendere una polisemia necessaria all’argomentazione, altrimenti passibile di non adeguata attenzione (come “constatazione/ammissione della propria (e della generale) precarietà”(p.67); “argomento/addestramento” (p.204); “una vis intuitiva/evocativa di vigorosa intensità/metaforicità” (p.180); “ammirabile/auspicabile” (p.122); la scansione grafica di componenti semantiche di una parola, per renderne la complessità originaria ed olistica (come “consola”, per sottolineare “lo stare con/presso chi è solo” e il sollievo derivato (p.14); “disprezzo: il ritenere questa o quella assenza/privazione giusto gravata da un prezzo/costo negativo/eccessivo da non pagare” (p.55); “Si dà – nel distacco, nella morte dell’ego (…) – vera convenienza, ossia un’opportunità e al contempo un venire incontro all’uomo da parte del mondo, in modo che esso risulti a noi un accordo, una concordia e un’armonia” (p.64) [la radice cord-, dal latino, richiama il cuore, n.d.r]); l’uso di termini rari o da lui costruiti per una maggiore aderenza concettuale (come “proprio di chi audisce, esaudisce” (p.14); “appropriatività”, per tradurre al meglio l’ungebunden eckhartiano).
Nonostante Meister Eckhart affermi che “Dio è in tutte le cose” (Sermone 77§4) e che “Tutte le creature sono un parlare di Dio” (Sermone 53§9), anche solo per “il miracolo dell’esserci”, aggiunge Roat, “Dio è una parola, che esprime [solo, n.d.r] sé stessa”; di lui non possiamo dire per verba, lo possiamo solo “balbettare” (Sermone 36§5), perché è alterità oltre le parole; perché, se lo si nomina, lo si definirebbe, rendendo singolare quello che invece è Tutto. “a Lui si può alludere tramite una parola poetica/poietica.”, dice Roat-autore di Beatitudine. Angelus Silesius e Il pellegrino cherubico, dove commenta la trasposizione in versi della dottrina di Eckhart da parte di A. Silesius, e comunque attento anche nei Sermoni a cogliere certe espressioni ‘poetiche’ del mistico. Roat coglie un aspetto importante non solo del dire poetico, ma del dire in genere. C’è infatti nella parola un toccare/fare segno, un reciproco relazionarsi tra l’‘io’ e il ‘fuori-io’, tra il pensiero della cosa e la cosa in sé, tra la assenza materica-evidente e la presenza astratta-ipotetica, che implicano un potere quasi magico, potenzialmente sacrilego e profanatorio, come nel caso della nominazione di Dio: la parola fa venire all’esistenza un qualcosa che può non essere presente, accertato, oppure ad esso solo adiacente, limitrofo, che perfino potrebbe non-essere. Come avviene spesso nella metafora, proporzione zoppa secondo Aristotele, dove l’assenza di nominazione per un’esperienza è risolta con l’uscita dall’ambito verbale nel mondo dell’esperire, per acquisire in adiacenza sensibile quell’esperienza altrimenti muta [i].
“la parola mistica – come per molti aspetti quella poetica o di certa innocua follia – tende a superare o a non tener conto dei limiti costrittivi della razionalità. Il mistico, il poeta, il folle sono (…) lievi, s’innalzano ascendendo a regioni eteree, (…) dicono senza tema di contra-dirsi. (…) un pensiero altro o forse, talvolta, giusto una sorta di non-pensiero.” pp.64-5
Anche qualificazioni positive come ‘buono’ o appellativi molto ‘vasti’ come ‘essere’ limitano Dio, quindi Meister Eckhart arriva all’affermazione (Sermone 82§6) che “Dio è nulla”, precisando che non significa inesistente, ma che “non è né questo né quello”, ma “un essere sopra ogni essere”, anzi, “un essere senza essere”. In un altro Sermone (83§6) Eckhart, leopardianamente, constata che “dobbiamo eternamente inabissarci dal qualcosa al nulla”. Soccorre all’apparente ossimoro Roat, ricordando che questo “nulla” è solo un modo di “dire l’indicibile”, è una metafora. Che indica una “trascendenza immanente”, un “divino (…) altro/oltre rispetto al mondo” ma che sta anche “nel mondo” (p.47). Roat apre quindi il confronto con il sûniatā buddhista, generalmente reso come ‘vuoto’, ma che, attraverso le parole del filosofo giapponese D.T. Suzuki, è da intendere quale “spazio non vacante”, che, pur senza esserlo, rende possibile il tempo, lo spazio, il divenire. Anche il niht eckhartiano, quindi, può essere letto come “pienezza” e “potenzialità” massime. Se Meister Eckhart dice che “Tutte le creature non hanno alcuna sostanza, perché la loro sostanza dipende dalla presenza di Dio” (Sermone 4§9), Roat commenta:
“Come a dire: c’è un’energia, una forza che tiene in vita gli esseri viventi e tiene insieme (con legami atomici o chimici, preciserebbe l’odierno uomo di scienza)) ogni cosa mondana. Senza questa dynamis le cose scomparirebbero (…) ogni cosa è presto o tardi transitoria, impermanente, frantumabile. Aggrapparsi alle cose (…) è illusorio.” (p.136)
Non può non affiorare alla mente lo stato dell’Universo precedente il big-bang; inoltre questo Dio che è “qual modo senza modo e qual essere senza essere” e che deve essere misurato “senza misura” (Sermone 71§14-15) ha tanto di simile alle caratteristiche delle microparticelle della fisica quantistica, la quale può davvero fare propria la conclusione eckhartiana “questa conoscenza è eminentemente senza modo e senza misura”. Che nemmeno vuol dire adombrare “una supposta realtà iperuranica”, ma soltanto dichiarare il
“mistero che cogliamo essere presente/insito nel mondo”, l’“intuizione (…) di un oltre (…) che esprime giusto il cuore segreto dell’immanenza (…) e indica/rappresenta il miracolo (o, se vogliamo, la mirabile possibilità stessa) dell’essere; consentendo la meraviglia (…) di fronte alla sola presenza di ciò che è un universo (…) mai esaustivamente comprensibile, dominabile, razionalizzabile” (p.104).
Potentemente attuale, anzi fuori di ogni tempo. Non fosse che Roat ci sbalza di colpo ad altro Sermone (21§6) in cui pare venga ribaltata la negatività di questo nulla: “Dio è Uno, una negazione della negazione”, in quanto “noi si divenga uno con Dio”. Ma qui si apre un altro tema.
L’UOMO E IL NECESSARIO DISTACCO DALLE COSE
Per arrivare a comprendere il divino, occorre rinunciare alla ricerca razionale, al sapere dogmatico e chiuso: Dio è “senza perché”. Ma soprattutto occorre distaccarsi dalla propria “egoità” – desideri, emozioni, valori, idee, attaccamento alle cose, anche spirituali, legame profondo col proprio ‘io’, anche la stessa eventuale ‘brama di Dio’ o attribuzione alla ‘volontà di Dio’, che, pur nella migliore delle intenzioni, esprime ancora un desiderio di bene personale. Viene in mente il rigore kantiano nel cercare la totale formalità e assenza di contenuti per le tre ‘massime’ morali, proprio per evitare questa limitazione all’imperativo categorico. Ogni stato, carattere, desiderio che abbia radice nell’‘io’ si rivolge al mondo per primeggiare, vuole porsi sopra e diviso dagli altri. Bisogna divenire, dice Eckhart ‘pitocchi’, ‘poveri di spirito’, raggiungere lo stato in cui si era prima di venire all’esistenza, arrivare al vuoto. Ma, come canta Silesius, “Diventare nulla è diventare Dio” (p.91), cioè una pienezza in cui stanno tutte le cose, dove il “molteplice [è n.d.r] come uno”. Il superamento dell’ego, non significa infatti, annientamento dell’‘io’, spiega Roat, ma è necessario per “sentirsi parte di Dio – o della natura per chi si professa ateo –, di un tutto che ogni cosa/ individuo comprende. L’io non è più visto come altro dal tu (da ogni tu). (…) Con la mors mystica (…) si giunge a cogliere “qualcosa” d’eccelso (…) da lui [Eckhart, n.d.r] chiamato “nulla”, ma che comunque, a suo dire: “E’ in parentela con la natura divina, è in sé stesso uno, non ha niente in comune con niente” (Sermone 28§6)” (p.90). È solo con una scrittura “poetico-immaginifica”, constata Roat, che il Meister può indicare per l’io un “farsi nulla che è insieme un indiarsi”, cioè “un nullificarsi divenendo Tutto.” (p.91).” Non può non affiorare alla mente lo stato dell’Universo precedente il big-bang. Dice Eckhart, citando forse Agostino, che Dio “adesso fa il mondo come nel primo giorno” (Sermone 38§5-6) e Roat lascia trapelare un sincero ‘entusiasmo’:
“felicemente moderna quest’idea di una creazione mai definitiva e in continua evoluzione: non necessariamente significando questo termine un progresso verso qualche fine, bensì uno svolgimento continuo, un perenne mutamento/divenire, che esprime la ricchezza potente del regno di Dio” (p.105)
E l’uomo che ha saputo abbandonare il proprio egocentrismo e il proprio esistere cronologico, che ha fatto in sé il vuoto per accogliere la pienezza, “egli opera con Dio” (Sermone 39§3), “fra lui e Dio non c’è più distinzione”: “Dio viene costantemente generato in quell’uomo” e “quell’uomo viene costantemente generato in Dio” (Sermone 40§3). Qui Roat ricorda la proposta “religiosa e al contempo originale e antichissima” di alcuni teologi odierni (tra cui Josè Maria Vigil e Mattew Fox) che, affermata la presenza divina “permeare” la natura tutta e l’uomo, “scorgono nella cosiddetta energia di fondo (o nel pregnant void: il vuoto gravido dei fisici) una sorta di fonte da cui tutto è emerso ed è in continuo divenire, preferendo comunque chiamarlo ancora Dio o una sua accettabile imago.” (p.114) L’uomo che “nulla vuole, nulla sa e nulla ha” si trova nella condizione in cui “era quando ancor non era”, la condizione originaria in cui “non aveva nessun Dio”, era “libero da Dio e da tutte le cose” (Sermone 52§8-9), perché lì, in quello stato “aurorale”, spiega Roat, non c’era nessuna individuazione, nessuna molteplicità, nemmeno “creatore” e “creatura”; Eckart è lapidario: “prima che esistessero le creature, (…) Dio non era “Dio”, bensì: era ciò che era.”, indicibile. Il “Dio” virgolettato è sorto dal bisogno, dall’immaginario delle/nelle “creature” (Sermone 52§9).
Se noi, creati, individuati, percepiamo “l’esistente come molteplicità”, dobbiamo però sentirci in comunione con “tutte le cose”, ‘riconoscerle’ un tutt’uno con noi, senza gerarchie, nella ‘radice’ da cui siamo ‘germogliati’ insieme. Dice infatti Eckart che le tante cose esistenti, il cielo, le include tutte e l’uomo è “beato/felice” quando il suo ego svanisce nella pienezza, nella “interezza” divina: “Io sono felice se tutte le cose e Dio sono in me.” (Sermone 65§3); “Tanto quanto tu sei inseparato da tutte le cose, tanto quanto tu sei Dio e tutte le cose, giacché la deità di Dio sta in questo fatto: che egli è inseparato da tutte le cose” (Sermone 77§4); infatti “Dio è qualcosa in cui tutte le creature necessariamente devono essere.” (Sermone 08§7).
Non si pensi, che Meister Eckart additi come modello l’asceta, chi si separa dal mondo in clausura, chi lo disprezza e condanna, tanto meno chi si abbandona all’indifferenza e all’apatia. Già nella scelta dell’evangelica Marta attiva, rispetto alla Maria contemplativa, indica infatti la preferenza dell’operare al bene degli altri con l’amore; ricorda infatti che chi si ritira dal mondo per cercare Dio fa certo del bene, ma solo a se stesso; mentre chi opera nel mondo con amore fa del bene agli altri.
Per me sta qui la grande complessità, l’originalità, l’attualità di Meister Eckart: non indica un Amore al di là della possibilità umana (e sono convinta che avesse conosciuto ed apprezzato come le Beghine del suo tempo questo Amore esercitavano nelle opere tutti i giorni, Margherita Porete fra tutte); non si limita a condannare l’individualità, ma la interconnette con tutte le cose fino a farne lo svelamento di un’unità originaria; osa davvero portare all’estremo significato la ‘somiglianza’ tra Dio e la creatura; non teme di andare contro/oltre la ragione, la logica della non contraddizione e di parlare in poesia.
Vorrei chiudere proponendo la sintesi dell’importante riflessione del fisico inventore del microprocessore Federico Faggin, (in Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura. Mondadori, Milano 2022), che, nonostante apparenti antitesi, mi pare coniugarsi più volte al pensiero di Meister Eckhart, qualche volta anche in salti d’intuizione oltre la logica:
“la coscienza è un fenomeno quantistico perché ha tutte le caratteristiche dello stato puro quantistico, ossia è uno stato ben definito, è uno stato privato perché lo stato puro non è clonabile, e quindi lo stato è conoscibile solo dal sistema che è in quello stato. Ciò riflette esattamente la fenomenologia della nostra esperienza interiore. (…) la nostra esperienza è un tutt’uno privato e in continua evoluzione, impossibile da descrivere completamente con simboli classici (le nostre parole), perché essa va oltre qualsiasi descrizione. La coscienza è la capacità di conoscere attraverso i qualia, cioè mediante le sensazioni e i sentimenti che portano con sé il significato di ciò che si conosce. La capacità di conoscere deve quindi esistere prima della conoscenza, e la conoscenza porta a esistenza ciò che si conosce per la prima volta. Conoscere diventa quindi sinonimo di esistere (…) l’evoluzione dell’universo parte da enti coscienti dotati di libero arbitrio che emergono da Uno. Uno è un tutto, sia in potenza che in atto, irriducibilmente dinamico e olistico, che vuole conoscere se stesso per autorealizzarsi. Uno è fatto di parti-intero, inseparabili e in continua evoluzione che da lui emergono e che comunicano tra di loro per conoscere se stesse. (…) Pertanto c’è un divenire nell’universo, e il futuro non è assolutamente predicibile, nemmeno da Uno.” (pp.13-4)
Molti temi, pur importanti, come l’Amore, la noluntas, il male, il confronto col pensiero orientale, ho tralasciato, soprattutto per rispetto verso l’attenzione percettiva dei mei quattro lettori, ma anche sperando che essi vadano a cercarli opportunamente sul libro di Roat. Un bel libro. Mi ripeto: prezioso.
[i] Esempio: non esistendo un termine che renda il rumore del mare in tempesta, Dante usa la metafora ‘mugghia’, muggisce, a proposito della ‘bufera infernal che mai non resta’. Il verso delle mucche, ‘muggito’ / è cupo-duro come è cupo-duro / il suono della tempesta marina (senza nome) (che per similitudine dovrebbe dare fisicità a quello della bufera infernale (senza nome)). In assenza di nome, si fa appello alla conoscenza sensibile, perché essa trovi nella memoria dei sensi, un’esperienza analoga a quella che si vuole nominare.

Lascia un commento